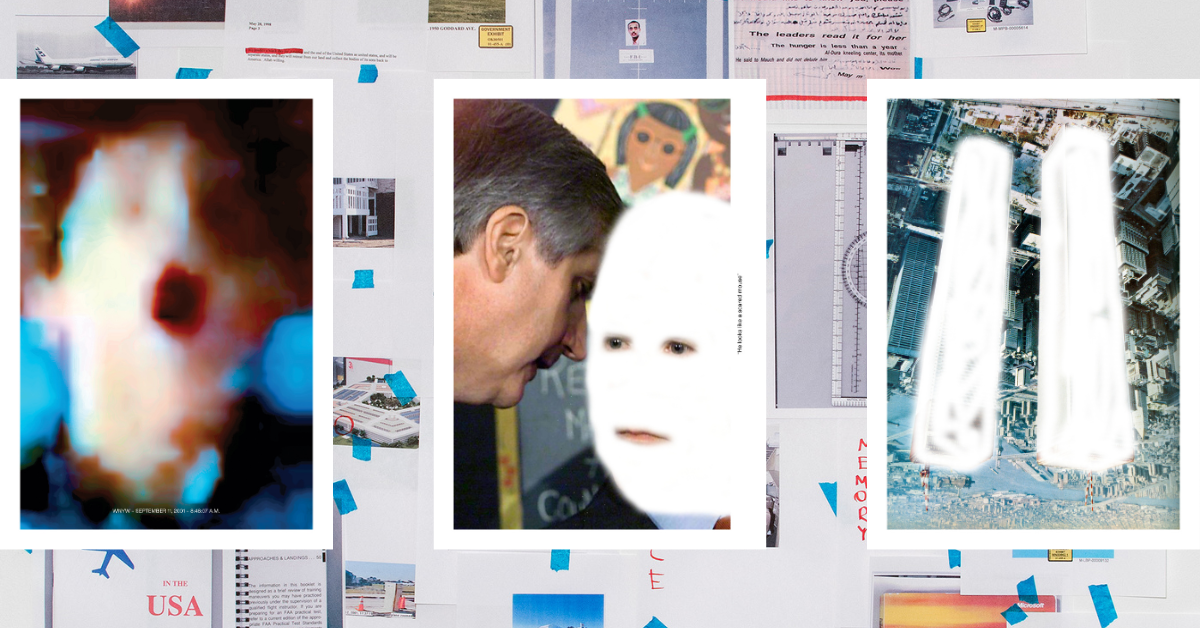Guardo il lavoro di Alessandro Calabrese (1983) dallo schermo del computer e la prima cosa che mi viene in mente è Tonio Cartonio. C’è un’immagine che ritorna in maniera incisiva, un frame di un’infanzia condivisa che visto oggi si carica di un significato che al tempo non eravamo in grado di percepire. È questa:

La Melevisione sullo sfondo, la Principessa Odessa e, appunto, un Tonio Cartonio dall’aria imbronciata, che già prefigura la reazione comune a tutti i tre/quattr/cinquenni di lì a poco. Qualche secondo dopo lo schermo si oscura fino al nero e lascia il posto all’edizione straordinaria del telegiornale. In quel frame, usciamo per sempre dal fatato mondo del Fantabosco per entrare “nella fine della fine della storia”. Sono circa le due di pomeriggio del 9 settembre 2001.
Con Calabrese siamo partiti proprio dall’apparente innocenza del Fantabosco per riflettere sulla capacità di alcune immagini di occupare il nostro orizzonte visuale. In più di vent’anni, com’è stato processato quel trauma? E che tipo di immaginario leghiamo a quell’evento?

Quella schermata congelata rubata alla Melevisione si lega con questa seconda immagine. Per un pubblico europeo sarà sempre e solo Derek Zoolander che alzandosi dal letto sbatte la testa in una trave. Per molti americani, invece, questo frammento visivo tratto dal trailer del film omonimo riveste la stessa funzione che per noi ha quello con la Principessa Odessa e Tonio Cartonio. La mattina dell’11 settembre, l’emittente televisiva statunitense WNYW è la prima a collegarsi con il World Trade Center, interrompendo bruscamente la sua programmazione e bloccando il povero Ben Stiller in un urlo di dolore destinato a non finire. È da considerazioni come queste che nasce l’interesse di Alessandro Calabrese per l’influenza dell’immagine sull’inconscio collettivo. Ed è dal trailer di Zoolander che è partito il progetto I’m Calling to Say I Love You.

Un inizio (I called)
I’m Calling to Say I Love You è una ricerca visuale iniziata nel 2018 che, dice Calabrese, nasce dalla fascinazione per il momento-prima, per quello che si nasconde dietro l’apice dell’azione. Il titolo allude alle note vocali e ai messaggi inviati da chi, la mattina dell’11 settembre 2001, si trovava sugli aerei dirottati o bloccato all’interno delle Torri Gemelle prossime al collasso, con un evidente rimando alla canzone di Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You.
Calabrese ha scelto di far scivolare il tempo verbale dal passato (I just called) a un present continuous (I’m calling), introducendo un chiaro elemento temporale, funzionale all’inquadramento concettuale del progetto. Non un’azione conclusa, quanto un loop che continua a ripetersi, oggi, a livello di memoria storica condivisa, come allora, nella mattina in cui tutto sta accadendo ma nessuno ancora lo sa. La complessità sta nel tentativo di dare forma a un momento invisibile, per il quale non esiste un’iconografia ben definita.
Al momento, Calabrese sta lavorando alla raccolta di note e appunti visivi che dovrebbero acquisire una forma video in un secondo momento. Lo scopo del lavoro è quella di provare a chiarire come la società Occidentale abbia affrontato il lutto collettivo dell’attentato al World Trade Center. Spazzate via tutte le (illusorie) certezze e le promesse del grande sogno americano, all’indomani dell’attentato, quali sono state le strategie con le quali si è affrontato l’evento storico? E in che modo l’Occidente ha fatto i conti con un’identità la cui ricostruzione è possibile solo per via frammentaria? Sono questi gli interrogativi che animano una ricerca in cui l’intimo in gioco non si riferisce solo all’individuo, quanto a un sentire massificato, collettivizzato, condiviso (via cavo al tempo, oggi sarebbe Internet).


Come spiega Calabrese stesso, lo spunto per un’indagine attorno a questo tema nasce guardando la prima pagina del “New York Times” dell’11 settembre 2001. In apertura non ci sono le Torri Gemelle in fiamme – come accadrà invece per l’edizione del giorno successivo – e niente allude all’attentato, se non sottili presagi di crescenti scontri tra Occidente e Medio-oriente. Siamo sul versante opposto rispetto al lavoro fatto da Hans-Peter Feldmann, che con il suo 9/12 Front Page ha messo in fila le prime pagine dei quotidiani di tutto il mondo che riportano l’attentato al World Trade Center.

Se il lavoro di Feldmann porta quasi a una ipostatizzazione e canonizzazione visiva del dramma nel suo culmine, quello di Calabrese mira a una cosciente interruzione della memoria volontaria con lo scopo favorire il recupero di un rimosso.
Per Calabrese, la pandemia ha rappresentato una cesura, un momento ideale per chiudere un discorso iniziato vent’anni fa, un modo per parlare di come sia cambiata la tragedia e di come noi siamo cambiati con essa. Dice Calabrese che “dell’11 settembre abbiamo sempre una rappresentazione scenografica, spettacolare, quasi attraente, tanto che Stockhausen l’ha definito ‘l’ultima opera d’arte del XX secolo’. Per un secolo l’arte ha provato a superare quello che è reale, finché con un colpo di coda questo evento diventa più vero del vero”. La realtà si riappropria della rappresentazione, si riafferma sulla rappresentazione, arrivando a parlare la lingua aniconica e trasparente dell’attimo prima.

È il ruolo dell’immagine, quindi, più che l’evento in sé, a essere centrale in questo lavoro. Nel libro Cloning Terror: The War of Images, 9/11 to the Present, W.J. Thomas Mitchell spiega che prima dell’attentanto alle Torri Gemelle una delle maggiori preoccupazioni a livello globale fosse quella della clonazione. Il problema indotto del terrorismo ha distolto l’attenzione da questo tema. Non solo. Con l’11 settembre viene azzerato qualsiasi tipo di interesse mediatico (ma soprattutto politico) per le rivendicazioni del movimento No Global, facendo cadere nel dimenticatoio Naomi Klein, il popolo di Seattle, Genova e il G8.
Non stupisca, però, che nonostante l’impatto di questo evento, Calabrese abbia scelto una modalità comunicativa che procede per prelievi di singole immagini non narrative piuttosto che per fotografie iconiche. I’m Calling to Say I Love You, infatti, acquista senso nel momento in cui si pongono in sequenza le varie immagini raccolte da Calabrese. È la fruizione d’insieme, e non il singolo fotogramma, a dare spessore al progetto. D’altronde, l’artista stesso ammette di non essere mai stato attratto dalle possibilità rappresentative della fotografia, quanto piuttosto dal concetto di riproduzione e clonazione applicato all’immagine fotografica. I metodi di propagazione e assimilazione dell’immagine del dramma come riflessione sulla risposta singola e collettiva rispetto a esso.

Limbi (I’m calling…)
A parte l’emittente locale WNYW, la mattina dell’attentato gli altri canali si collegano con circa due minuti di ritardo. Tra l’interruzione dei programmi e il collegamento con le immagini in diretta vi è un intermezzo pubblicitario. Sono gli ultimi momenti di non conoscenza di ciò che è in atto, il limbo visivo che separa il prima e il dopo. Rispetto alle pubblicità, le immagini in diretta rappresentano quasi un bug, un’anomalia non prevista che obbliga a considerare l’inatteso. E questi spot promozionali hanno per Calabrese un interesse peculiare. In un’epoca in cui i colpi di stato vengono trasmessi in diretta Intagram, fare i conti con un evento come l’11 settembre obbliga a un’analisi introspettiva su chi eravamo vent’anni fa e su cosa rimane, oggi, di quell’evento. Per esempio, parlando con Calabrese ci siamo resi conto che forse non tutte le nuove generazioni, in futuro, avranno lo stesso grado di partecipazione e la stessa capacità di lettura di immagini come quelle dei falling men.
Certamente, lo scatto di Richard Drew finito sulla copertina del “Time” è destinato a occupare il nostro orizzonte culturale ancora per molto tempo. Ma se decontestualizzate, le molteplici varianti di quella fotografia con il medesimo soggetto saranno ancora in grado di trasmettere lo stesso senso di disperazione a chi nel 2001 non era ancora nato? Suicidio in mondovisione per evitare un destino di cui non ci si sa capacitare o cliff diving estremi stile Jackass sponsorizzati da qualche bevanda energetica iperzuccherata? Gradualmente vanno a stemperarsi le chiavi di decodifica di un certo universo visivo e con esse muta il nostro l’orizzonte visuale. Di conseguenza, la porosità e la permeabilità dell’immaginario condiviso si fa manifesta. È come se le maglie del linguaggio fotografico si facessero larghissime, sottoposte a spostamenti di senso, alla soggettività dell’osservatore, al contesto, alla metodologia di fruizione.

“Qualche tempo fa avevo anche provato a contattare Richard Drew, il fotografo che aveva realizzato lo scatto del falling man, per vedere quali altre foto ci fossero nello stesso rullino, quali soggetti erano stati fotografati prima dell’attentato”, spiega Calabrese. “Indubbiamente quello della leggibilità dell’immagini è un grosso problema, anche perché se fino a qualche anno fa ci si poteva ancora illudere rispetto alla veridicità dell’immagine, oggi vediamo che questo non è più possibile. La fotografia in quanto racconto, documento, rappresentazione è morta, finita. Il realizzare immagini finte ma credibili sarà sempre più facile, come dimostra l’immagine del Papa che indossa un modello di Moncler”. ChatGPT, Dall°E Mini, AI… si fa fatica a trovare un qualche tipo di giustificazione artistica, anche se, come dice anche Calabrese, “a questo giro c’è puzza di serietà”. La de-autorializzazione dell’immagine digitale sembra essere qui per restare ed è anche il motivo per cui per I’m Calling to Say I Love You si può parlare di preistoria del fotografico.

Davanti a immagini come quelle dei falling men, Calabrese confessa di pensare esplicitamente a David Faster Wallace, che precorrendo i tempi in Infinite Jest scriveva:
«The so-called ‘psychotically depressed’ person who tries to kill herself doesn’t do so out of quote ‘hopelessness’ or any abstract conviction that life’s assets and debits do not square. And surely not because death seems suddenly appealing. […] Make no mistake about people who leap from burning windows. Their terror of falling from a great height is still just as great as it would be for you or me standing speculatively at the same window just checking out the view; i.e. the fear of falling remains a constant. The variable here is the other terror, the fire’s flames: when the flames get close enough, falling to death becomes the slightly less terrible of two terrors. It’s not desiring the fall; it’s terror of the flames. And yet nobody down on the sidewalk, looking up and yelling ‘Don’t!’ and ‘Hang on!’, can understand the jump. Not really. You’d have to have personally been trapped and felt flames to really understand a terror way beyond falling»
Particolamente interessante, quindi, che sia proprio Foster Wallace, qualche anno dopo, a darci un esempio della rappresentazione del dramma nel momento in cui questo è ancora in atto. In The View from Mrs. Thompson’s, articolo originarimente pubblicato su “Rolling Stone” e poi incluso in Considera l’aragosta, Foster Wallace descrive il suo 9/11 a Bloomington, Illinois. Foster Wallace non concentra la sua attenzione sugli eventi esteriori della tragedia: non parla delle torri in fiamme, né delle vittime che tentano di salvarsi lanciandosi nel vuoto – almeno, non direttamente. Ad interessare lo scrittore americano è invece il modo in cui i cittadini di Bloomington rispondono emotivamente all’evento, ognuno esponendo la bandiera americana in segno di solidarietà e appartenenza a determinati valori culturali. E, di conseguenza, chi legge scopre come anche lo scrittore si ritrovi costretto a procurarsi una bandiera da esporre, per non incappare nel biasimo dei vicini.
Come nel progetto di Calabrese, a interessare Foster Wallace sono i segni esteriori della catastrofe, che non sono la catastrofe e nondimeno le danno una forma visibile. Però, se nella prosa di Foster Wallace siamo temporalmente dopo l’impatto degli aerei, quando ormai le coscienze sono già state scosse, con I’m Calling to Say I Love You siamo prima che questo accada. Il tentativo comune in entrambi i casi è comunque quello di riflettere sui possibili approcci collettivi rispetto alla Storia nel suo farsi. E, per citare solo un altro esempio attinente, come non ricordare il Don DeLillo di L’uomo che cade? Anche in questo caso, il romanzo si concentra non sul mentre, quanto sul dopo e sulle conseguenze provocate dal crollo delle Twin Towers. Significativo, però, che a fronte di tanta letteratura che riflette sul lascito traumatico dell’11 settembre, pochissimi abbiano lavorato sugli attimi precedenti, come invece sta facendo Calabrese. Un modo diverso per affrontare questioni relative alla nostra identità, che obbliga a fare i conti con chi eravamo prima di quell’evento e non solo su chi siamo diventati dopo.

Ground zero zero zero (I will call…)
La 25° ora è un film di Spike Lee del 2002. È la prima volta che al cinema viene mostrato Ground Zero. La casa di uno dei protagonisti, Frank (Barry Pepper), affaccia esattamente sopra il luogo dell’attentato e quando l’amico Jacob (Philip Seymour Hoffman), guardando le macerie da una finestra, gli chiede se abbia intenzione di cambiare casa, la risposta è laconica:
«Non ci penso neanche… con tutti i soldi che ho pagato per questo posto! Cazzo, no. Neanche se Bin Laden ne lanciasse un altro contro il palazzo accanto»
La storia irrompe nel vissuto privato e il privato reagisce come può, rivendicando il diritto al possesso di terreni e abitazioni. L’esorcizzazione del dramma collettivo passa anche per minuscoli frammenti di quotidianità scossa e sono proprio questi frammenti a comporre la visione d’insieme nel mosaico di Calabrese. Procedendo per interferenze di segni, détournement, risemantizzazioni il patrimonio visivo diffuso rientra in circolo sottoforma di film, reportage, meme, pubblicità – che sono poi il cuore di I’m Calling to Say I love You. Che dire per esempio della fake “adver-memorial” attribuita a Subway dal sito satirico “The Onion”? O della (vera) pubblicità lanciata da AT&T per pubblicizzare i propri cellulari? Ma quanto di tutto questo continuerà a occupare l’immaginario delle prossime generazioni?
Con I’m Calling to Say I Love siamo nel terreno della rimozione, del sommerso in quanto schiacciato dalle macerie – fisiche, oltre che virtuali – della narrazione mainstream. In questo senso, si naviga dalle parti dei counter-monument teorizzati da James E. Young, solo che qui non c’è niente di concretamente fisico. Se nelle opere di artisti come Jochen Gerz o Hans Haacke si parte dal monumento per dare forma a un vuoto, in questo caso si procede all’opposto e dalla mancanza, dall’indicibile in quanto non rappresentabile, si arriva a una composizione dove le immagini assumono valore indicale più che simbolico.
E a proposito di rimossi e rimozioni, guardando il tweet di AT&T è interessante sapere che nell’immediatezza del lutto la Sony censurò in tutta fretta lo Spider-man di Sam Raimi, dove il World Trade Center faceva da sfondo a molte scene. “Ci sono alcuni film in cui le Torri Gemelle sono state rimosse digitalmente, ma in alcuni frame si vedono riflesse. Anche questa è una parte che vorrei sviluppare per I’m Calling to Say I Love You. Se oggi la cancel culture mira a rimuovere i simboli delle ingiustizie che l’Occidente ha perpetrato contro altri popoli, vent’anni fa si rimuoveva per proteggerci da qualcosa che avevamo subito. È un processo interessante su cui vale la pena riflettere”, commenta Calabrese.