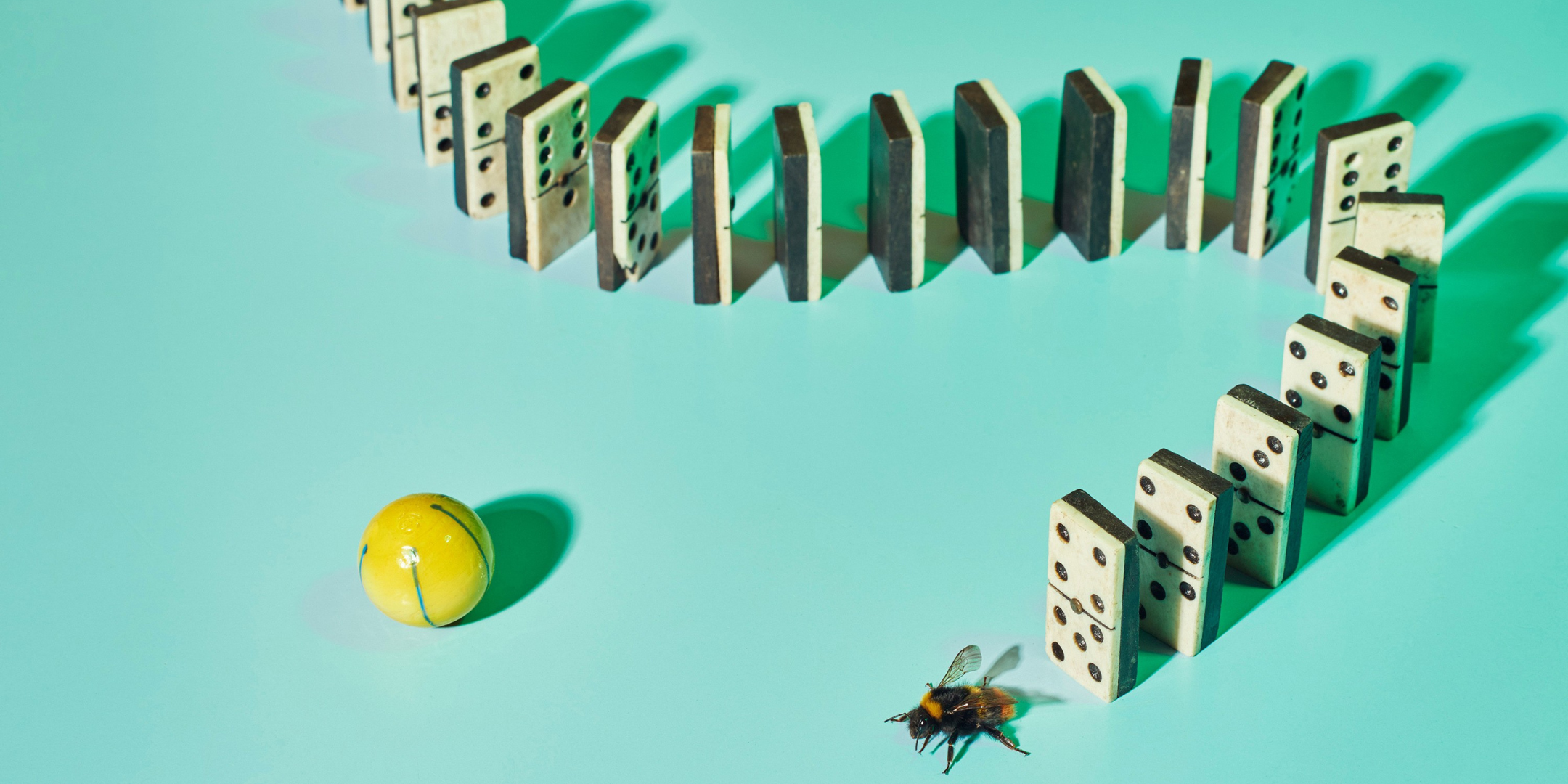Attenzione: questo articolo è editato in modo da essere leggibile in due versioni, una completa e un ridotta.
Per chi legge da computer: le colonne a destra corrispondono alla versione ridotta e possono essere saltate.
Per chi legge da telefono: le parti racchiuse fra due asterischi fanno parte della versione integrale e possono essere saltate (sono legate ai paragrafi di riferimento dagli apicali: 1,2,3…).
In ogni caso si raccomanda la visualizzazione da computer per un’esperienza di lettura più confortevole.
Sei capitato nel quinto articolo della rubrica Odissea nel Quaderno, dedicata alla recensione delle sillogi contenute nel XV Quaderno di poesia contemporanea, (a cura di Franco Buffoni, Marcos y Marcos 2021). Questa volta ci occuperemo della silloge Nuovi modi per uscirne, di Simone Burratti. Qui puoi trovare le altre uscite.
Più volte Franco Buffoni, discutendo della storia e del progetto fondativo dei Quaderni italiani di poesia contemporanea (qui un esempio recente), ha sottolineato la volontà di lasciare uno spazio alle scritture non tradizionalmente liriche. Eviteremo di dire sperimentali: come ormai si sente dire sempre più spesso (per fortuna), anche una scrittura lirica può benissimo essere sperimentale. Al di là dei problemi di nomenclatura, comunque, le varie edizioni dei Quaderni hanno rispettato, con qualche eccezione, l’intento del loro ideatore (ma su questo torneremo alla fine). Pochi dubbi che in questo Quaderno XV gli autori più disponibili ad allontanarsi dal solco lirico siano Sara Sermini, con la sua «tecnica metalinguistica» già ben indagata da Roberto Batisti su queste stesse pagine, e Simone Burratti, a proposito di cui proporrò qualche spunto.
Antefatti
Burratti è reduce da un esordio, Progetto per S. (NEM, 2017), di cui diversi critici hanno sottolineato l’originalità, che potremmo ricondurre, sintetizzando con un po’ di brutalità, a tre punti:
1) Scelta di scrivere la maggior parte dei testi in una prosa di registro medio, con sintassi piuttosto lineare e scarse escursioni lessicali verso l’alto o il basso;
2) Presenza di un soggetto che, se da una parte non si eclissa nel tentativo di raggiungere la non-assertività del testo (come avviene in tante scritture di Prosa in prosa e discendenze varie), dall’altra mostra un atteggiamento di «impietosa analisi del proprio squallore», realizzando «un’autopsicografia non lineare, un autoritratto cubista a toni atroci e terrei» (entrambe le citazioni da Batisti).Come ha scritto Claudia Crocco, il ricordo più forte che rimane al lettore di Progetto per S. è la «generale cupio dissolvi percepibile in ogni pagina»; le classiche vie d’uscita dell’atteggiamento compiaciuto da maudit, depressione e cattiverie alcoliche di ogni tipo, in Burratti sono sì presenti, ma quasi trattate con noncuranza, palloncini sgonfi e scoloriti buttati in un angolo del pavimento, incapaci di far anche solo presagire una qualche forma di trascendenza. L’intento, insomma, è quello di scardinare ogni forma di auto-illusione dell’uomo (ma direi proprio: del giovane) occidentale cólto, che non riesce a smettere di ritenersi, tutto sommato, una persona speciale;
3) Capacità di puntellare il paesaggio asfittico della clausura domestica (non certo una novità nella poesia degli ultimi decenni) con aperture all’immaginario generazionale: videogiochi e altri figuranti informatici, canzoni non scontate nel panorama colto (andando oltre il cantautorato: un testo, in particolare, rielabora una canzone dei Tool), fumetti1.

Prosa adottiva
L’illustre prefatore cita, proprio all’inizio del suo intervento, uno scritto critico di Burratti del 2016, intitolato L’autore indifferente: quasi a confermare l’idea di una produzione creativa iper-consapevole, germoglio intelligente di una puntuale visione della letteratura e delle sue possibili funzionalità. Ho l’impressione, però, un po’ come si lasciava già intendere qui su Lay0ut riguardo a un’altra coppia di questo Quaderno, cioè Pusterla e Meloni, che Mazzoni non faccia il servizio migliore al suo “assistito”, che tende a inglobare in una prefazione forse troppo a tesi, complice la comodità d’inserire Progetto per S. nello stesso lignaggio della sua opera La pura superficie (Donzelli, 2017) – senza mai dirlo esplicitamente, è ovvio. Le parole chiave che emergono sono almeno due: indifferenza e scrittura neutra. Mazzoni nota – lo ricordavamo anche noi poco fa, punto 1 – la mancanza di «escursioni lessicali e figurali troppo vistose» (p. 67) e colloca Burratti in una terza (salvifica) via tra due tipi di poetese, quello tradizionale e quello delle avanguardie: a proposito di entrambi, il referto del critico-medico è inesorabilmente sicuro («le due famiglie più diffuse e morte»).
Nelle parole con cui l’autore di Sulla poesia moderna (Il Mulino, 2005) presenta i testi di Burratti, si legge – neanche troppo in filigrana – l’apologia della scrittura schermata e della studiata mediocrità dell’io autoriale che Mazzoni ha scelto per tradurre in atto e forma i suoi postulati critico-letterari. Un’indifferenza come tratto morale, veicolata da un grado zero di scrittura che, più di una urgenza espressiva, sembra la constatazione della mancanza di qualsiasi urgenza: «Ho scritto un testo che non tende a nulla. Vuole solo esserci, come tutti. Ho scritto un testo che rimane in superficie», recita una pericope spesso citata dalla Pura superficie. E per chi si chieda «ma se non hai urgenze, perché pubblichi?» la risposta è già servita: perché Mazzoni parla ad un gruppo sociale coeso e a lui solidale (intendo l’aggettivo nell’accezione linguistica: la solidarietà semantica tra due parole è la mera tendenza a presentarsi spesso all’interno dello stesso sintagma), cioè quello degli addetti al lavoro culturale.
In questo ristretto contesto, anche testimoniare la non urgenza può avere senso, perché come dicevamo prima può essere utile a riempire lo iato illusoriamente costruito tra l’individuo cólto e gli altri. Ed infatti La pura superficie ha fatto una delle poche cose – disclaimer: sono un po’ pessimista – rimaste da fare a un libro di poesia-poesia oggi, cioè sollevare un dibattito interno e muovere un filo le acque2.


Eppur si muove
E, venendo appunto ai testi, emergono subito con chiarezza alcune costanti nella poesia in prosa (la chiamiamo così per mera comodità, dando per scontati i distinguo fatti in precedenza) di Burratti, che la distinguono sia da quella di Mazzoni, sia dagli altri modelli più spesso chiamati in causa, cioè la triade (molto eterogenea, a dire il vero) Dal Bianco/Bortolotti/Broggi, e dimostrano l’autonomia dell’autore nel percorrere una via propria.
Il tratto più evidente è che nella silloge di Burratti la moltiplicazione delle prospettive e la frammentazione dei punti di vista sono molto meno spinti: la direzione dello sguardo e della narrazione, al di là dei salti, delle ellissi e delle torsioni quasi inevitabili in qualsiasi area post-lirica, appaiono tutto sommato sotto controllo. Ciò è coerente con il progetto di fondo di questa poesia: soltanto ponendo l’io dell’autofiction con continuità al centro dell’attenzione, infatti, e di un’attenzione auto-cannibale, spietata e demistificante, l’io autoriale riesce finalmente a scostarsi dalla ribalta. Questa dinamica riesce meglio quando s’intreccia con la mimesi di atti linguistici performativi, come in 7-5-8 (p. 77):
Adesso siediti. Rilassati. Espira con lentezza, stringi gli occhi nel pensiero e dimmi: com’è la vita senza un significato?
Dormire senza sonno, non sentire il sapore del cibo. E quel prurito continuo ai capelli, sotto i bulbi, che scava tra le placche del cranio come per estrarre il vuoto3.

Tuttavia, smorzare lo stile come principale strumento di costruzione dell’identità poetica, con l’intento di rappresentare la debolezza e la non-eccezionalità dell’io («Non sei speciale, sei solo strano», p. 77), è una soluzione formale che richiede una grande potenza inventiva e un grande controllo della coesione testuale, affinché il singolo componimento mantenga sempre un’adeguata tensione espressiva. È proprio questa continuità a mancare nelle sequenze di Burratti. E se Mazzoni, nell’introduzione, scrive che «Burratti lavora […] sulla sintassi, sullo straniamento e sul ritmo interno della frase» (p. 67), a me pare che proprio da questo punto di vista gli esiti siano molto alterni. Così, si va da sequenze molto convincenti, come la prossima, in cui l’autore sa plasmare la sintassi in una coordinazione nevrotica e capace di mutuare un andamento infantile e violento:
«posso raccontare una storia e cioè quella della noce in mezzo agli occhi, che è simile al tumore di mio nonno ma meno grande di una palla da golf, la mia noce è più piccola e soprattutto la custodisco con cura nel comodino tirandola fuori solo in caso di pericolo, irrequietezza o stizza, odio e elettricità, quando sento che il braccio mi diventa gigantesco e vorrei colpire un muro […]» (p. 87).
A molte altre in cui, volontariamente o meno, Burratti tende ad appoggiarsi a moduli sintattici prevedibili, che se non vengono innervati da un montaggio davvero forte a livello iconico, o capace almeno di simulare tensione narrativa, rischiano di limitarsi all’enunciazione del referto. Probabilmente l’obiettivo è proprio questo, è vero: ma ciò non toglie che una prevedibilità di questo tipo s’inserisca in uno schema cólto (elenchi simili si trovano spesso negli autori-modello di Burratti) molto ammiccante, e in contraddizione con gli intenti demistificatori di cui dicevamo prima:
«Smettere di bere, svegliarsi a un’ora decente, avere rispetto per la sofferenza degli altri, per l’amore degli altri. Dormire con attenzione, portare ogni decisione stampata in fronte, severamente e serenamente. Inspirare fino alla pelle d’oca
Scegliere di rompere amicizie durate secoli, buttare via selezioni di fiducia. Dimenticarsi abitudini e persone […]» (p. 85);
«Tutto quello che non posso fare più: vestirmi, camminare per strada con la schiena decisa, con il braccio delimitare lo spazio; e riprovare, e tagliare la carne […]» (p. 95)4.

Anche per quanto riguarda il ricorso all’immaginario generazionale e antipoetico, i risultati sono alterni. Alcuni inserti di questo tipo rimangono davvero impressi, soprattutto quando dondolano sul filo sottile tra significato letterale e figurale («Come le punte del tappetino mysa possono farti sentire dolore, se non sono abbastanza sottili da trapassarti», p. 80; «C’è il sole, come se niente fosse. S. lo nasconde con l’icona del Cestino», p. 111); e uno dei testi più belli di Burratti, per quanto mi riguarda davvero vicino alla perfezione, è uno pseudosonetto (14 versi con misure dominanti di 11 e 9 sillabe) dedicato alle batterie dei computer che si usurano.
Ma altre volte le sovrapposizioni stranianti e potenzialmente efficaci (come quella tra le reazioni dell’auto al telecomando e le feste di un cane in Nano di notte, p. 79) si esauriscono lì, senza che lo spunto iniziale, tutto sommato, si accenda mai veramente. Anche i figuranti informatici possono condensare sintesi potenti («Bisogni fisiologici, azioni scriptate», p. 105: in quattro parole l’eclissi del libero arbitrio) o rivelarsi tessere un po’ grossolane («Mi sento obsoleto come un telefono intasato dai troppi aggiornamenti», p. 94; «tu che rimani sempre la mia password del wi-fi», Pinguini Tattici Nucleari: al di là dello spleen, non vedo grandi differenze retoriche).
Un ultimo spunto d’analisi: quando Mazzoni scrive che Burratti, pur parlandone e praticandole (sempre tramite l’io dell’autofiction, s’intende), non crede nelle classiche vie d’uscita da maudit (alcool, sesso, pornografia), motiva il disincanto col fatto che esse implicherebbero una richiesta di trascendenza, «che non si può dichiarare perché diventerebbe ridicola» (p. 70). Ecco: allo stesso modo, la sensazione è che le scelte stilistiche di Burratti, così fortemente sostenute dal critico, non servano solo a metterci la faccia attraverso un «modello di io e dizione credibili» (ibidem) (come sostiene Mazzoni, in opposizione alle scritture di ricerca che si sottraggono alla natura idiota del reale attraverso la virgolettatura di tutto), ma anche proprio a non rendersi ridicolo, cercando uno spazio che tutto sommato nella poesia italiana è poco calpestato, e garantisce spazi di manovra più larghi, ma in cui non mi sembra di vedere né una particolare forza innovativa (a livello contenutistico e critico-culturale) né motivi sufficienti per farmi credere che le risorse espressive della poesia scritta siano più adatte ad indagare questi temi (la rappresentazione dell’indifferenza del soggetto, l’incapacità di vivere, la perdita dell’entusiasmo, ecc.) rispetto alla pletora di serie televisive che oggi scavano nelle stesse dinamiche con acuta profondità psicologica.
Anche il basso continuo stilistico che cerca Burratti, insomma, può essere una strategia per tirarsi fuori dai rischi, pur senza le virgolettature della poesia di ricerca. Forse è per questo che, quando l’autore tenta qualche scarto di registro spingendo maggiormente sul pedale dell’enfasi, c’è spesso la sensazione che cammini sui vetri rotti, inciampando in ripetizioni e anafore quasi crepuscolari («La promessa, formulata in silenzio e lasciata chissà dove, di rimanere così, sempre così», p. 84) o in uscite gnomiche che stonano con l’autorappresentazione mediocre dell’io («Le sentenze peggiori escono dalle bocche distratte», p. 83)5.

Altre prospettive
Il fatto che la postura poetica attuale di Burratti rappresenti la poesia post-lirica, e che come tale venga proposta nei Quaderni, mi sembra invece un problema maggiore. Sotto questo aspetto, il provincialismo del dibattito poetico italiano è molto più evidente: perché, rispetto a quanto si vuole far apparire, ci sono molti più spazi per il nuovo, esistono ricerche meno abbozzolate, e molti modi affinché questo nuovo mantenga un barlume di proposta etica, di costruzione comunitaria.
Con la poesia in prosa, e sempre adottando un soggetto dimidiato e non certo moralmente assertivo, fin dagli anni Sessanta e Settanta in America si è fatto molto di più. Basti l’esempio, familiare a chi legge Lay0ut, di Russell Edson, autore capace di spogliare la poesia con l’irriverenza delle sue ossessioni e l’esattezza del linguaggio, ironico e anti-accademico, ma senza per questo sigillare la porta della narrazione, e anzi lasciando intuire un luminescente, per quanto paradossale, stato di grazia (come l’ha definito Pacini).
Penso anche, per rimanere nei nostri confini, alla poesia di Andrea Raos, ugualmente capace di rimanere orizzontale e di rinunciare a vie di fuga metaforiche, ma – diversamente dai testi di Burratti, o almeno da quelli usciti nel Quaderno – capace comunque di tutelare una dimensione di ascolto. Inoltre, si può praticare un tono profondamente anti-poetico e anti-letterario senza che ciò faccia perdere intensità e agonismo alla sfida conoscitiva della poesia: penso a Carlo Bordini, per non parlare dell’anarchia intelligente di Cristina Annino. Insomma: non facciamo passare come nuovo ciò che, non certo per colpa dell’autore, ma piuttosto del contesto poetico italiano, non è esattamente un’avanguardia coraggiosa nella proposta e nelle forme.
Mi chiedo se i selezionatori dei Quaderni abbiano avuto davvero l’intenzione di andare a cercare chi, fra i poeti post-lirici di oggi (se ne esiste qualcuno all’altezza, ovviamente), abbia le ambizioni etiche ed estetiche di chi li ha preceduti, in questo ruolo, nelle raccolte a cura di Buffoni degli scorsi due decenni. La lista dirà più di molte parole: nel Quaderno XIIc’era Lorenzo Carlucci, nel IX Maria Grazia Calandrone e Marco Giovenale, nell’VIII Luigi Socci, nel V Andrea Raos.Rispetto a questi autori, il restringimento della prospettiva nel Quaderno XV è evidente.
La sintesi finale del problema ce la serve lo stesso Burratti, in una delle sue spietate autoanalisi: «Ho sempre voluto essere l’artefice degli avvenimenti, ma senza alcun interesse per gli avvenimenti in sé» (p. 98). L’autoanalisi, però, va poco oltre la constatazione di un dato di fatto generalizzato. Ecco: quando rivedremo nei Quaderni un autore che, senza accomodarsi sulla strada rassicurante del lirismo epigonale, si ricordi anche di avere esattamente la responsabilità, in quanto poeta in rapporto etico e agonistico col reale, di farlo riscoprire, quell’interesse per gli avvenimenti in sé?


*
1) Nel Quaderno XV Burratti ripropone due sezioni tratte da Progetto per S. (seconda e quarta: Scegliere e Quadrato) e ne aggiunge due inedite (prima e terza: Dove ero rimasto e Come un erasmus). Nella Nota (p. 112) l’autore specifica di aver scelto i testi inediti secondo il criterio della continuità con l’opera precedente: i pregi e difetti di cui diremo, quindi, riguardano ciò che possiamo leggere ad oggi, al di là di eventuali cambi di rotta cui l’autore stia lavorando.
Un primo dato interessante, ad esempio, è che nelle sezioni inedite la mise en page prosastica non è più così dominante: sono in prosa (per intenderci: i brani con il testo giustificato e con pochi accapo, visto che anche in quelli in prosa, in realtà, la divisione in blocchi di testo/strofe è frequente) un testo su quattro nella prima sezione e 5/8 nella terza. Come dice Guido Mazzoni nella sua introduzione, in effetti, la sensazione è che Burratti si muova in un confine fluido fra poesia e prosa, e non voglia fare né dell’una né dell’altra una marca stilistica così netta.



*
2) Tuttavia, ho l’impressione che quella sorta di ciclo dell’indifferenza implicito nella presentazione di Mazzoni (l’io poetico non è differente dagli altri individui; l’io poetico è apatico e chiuso al mondo, dunque incapace «di dirsi “che ne vale la pena”», p. 69) rischi di ridurre gli angoli di lettura del lavoro di Burratti. Ad esempio, sempre nell’Autore indifferente, la parola chiave torna, qualche paragrafo dopo il passo citato da Mazzoni, in un’accezione a mio parere più complessa: un dispositivo che crea frizione tra il tentativo malriuscito dell’io di ritrarsi e annullarsi di fronte ai processi programmati della realtà, e la capacità che proprio quest’arresa ha di scucirgli un’estrema, involontaria apertura:
«Ma l’autore, si sa, non è mai indifferente, ed eccolo lì pronto a imporre a quel mondo la sua personale visione, riducendolo così a uno dei tanti possibili, insufficienti. Eppure, dall’attrito del suo intervento ordinatore con la realtà decentrata e informe – leggasi: informale –, qualcosa è nato, e già non gli appartiene più: una frase scappata per sbaglio, una contraddizione non salvabile, una regola che torna invariabilmente. La sua scrittura, la sua idea di mondo, finisce per rientrare nei processi programmati dal tempo in cui è stata concepita; e proprio per questo, dal suo punto di vista parziale e ininfluente, è costretta a parlarne nel modo più schietto, concreto, l’unico possibile: quello in cui il suo autore non ha più importanza, né sa opporsi al testo (al mondo?) che lo esclude»
È rispetto a questo intento più ampio (ma anche sfuggente) che sarebbe utile interrogare gli esiti formali dei testi di Burratti.


*
3) Alla prima parte, con imperativi probabilmente rivolti a sé stesso, segue un secondo blocco di testo spersonalizzato, in cui l’unico verbo all’indicativo ha un referente inanimato e, non a caso, patologico (prurito). Efficaci sono pure i momenti in cui la quotidianità concreta dei realia domestici viene fatta collidere con la psicologia:
«Fuori dal frigo, le aspettative prendono il colore del latte avariato. Le frasi a punta cadono perpendicolari al letto. All’improvviso non sono più forte» (p. 94)
«Mi sento triste in un modo che fa chiudere le finestre» (p. 98).
Così come quelli in cui la narratività si condensa in brevi isole di surrealtà, che Burratti è bravo a mantenere tali, senza cedere alla tentazione di diluirle:
«Il nano sbuca fuori dal letto all’improvviso, scintilla i denti gialli masticando gli asparagi. Ride, sputa, dice te l’avevo detto. Quando mi giro sul fianco mi abbraccia, mi lascia dormire» (p. 99).



*
4)
Un altro schema prevedibile e ultra-letterario che torna più volte è quello ternario: «Una presa di coscienza, un proposito, un tentativo di responsabilità» (p. 85), «Un edema, un ronzio, una macchia blu» (p. 93), «Negare, sovrascrivere. Ricostruire» (ibidem). Burratti non riesce insomma a liberarsi, a mio parere, di una letterarietà di fondo.
Chi volesse avere prova di cosa può succedere quando si riesce a inglobare radicalmente nel dettato moduli dell’oralità o comunque estranei alla tradizione poetica scritta, in un equilibrio difficilissimo tra parodia, invenzione iconoclasta e decostruzione, può andarsi a leggere Walkthrough di Manuel Micaletto, dove c’è un lavoro sulla sintassi a mio parere molto più compiuto e radicale.
La scarsa vivacità coesiva dei testi emerge anche quando Burratti tenta di simulare la prosa argomentativa: in assenza di una ritmica interna forte, non c’è frizione che percuota il lettore: così, nella prossima citazione, quella che avrebbe potuto essere una climax rimane soltanto cronaca orizzontale del non senso naturale.
E se uno sguardo di questo tipo, forse non estraneo a una muta commozione, può avere un potenziale critico quando lo opponiamo a certo tardo-lirismo naif, rimane il fatto che siamo ben lontani dai territori dell’originalità: nulla che, in cinematografia, Mondo cane non avesse già proposto nel 1962:
«I dobermann diventano cattivi perché il loro cervello cresce troppo, così tanto da non poter più essere contenuto nel cranio: la materia grigia spinge contro l’osso, sotto la pressione delle gengive i canini si sporgono fino al dolore, fino ad usarli» (p. 78).




*
5) Anche se gli aspetti non convincenti mi sembrano molti, gli alti e bassi della poesia di Burratti sono quasi inevitabili, vista l’età dell’autore. In testi come Astronavi (p. 108), anzi, scorgo possibilità di sviluppo interessanti: l’uso della prima persona e il dettato colloquiale collaborano con un montaggio vario e ben studiato, in cui la prosa si alterna al verso; i labirinti mentali del monologo mantengono la loro disperazione, ma anche qualche spazio per una vicinanza, seppur disincantata (un po’ come nei momenti più alti della Pura superficie).

Leggi anche gli altri articoli di Discorsi!
Copertina e apparato iconografico: Kourtnei roy, dalle serie northen noir e monster inside