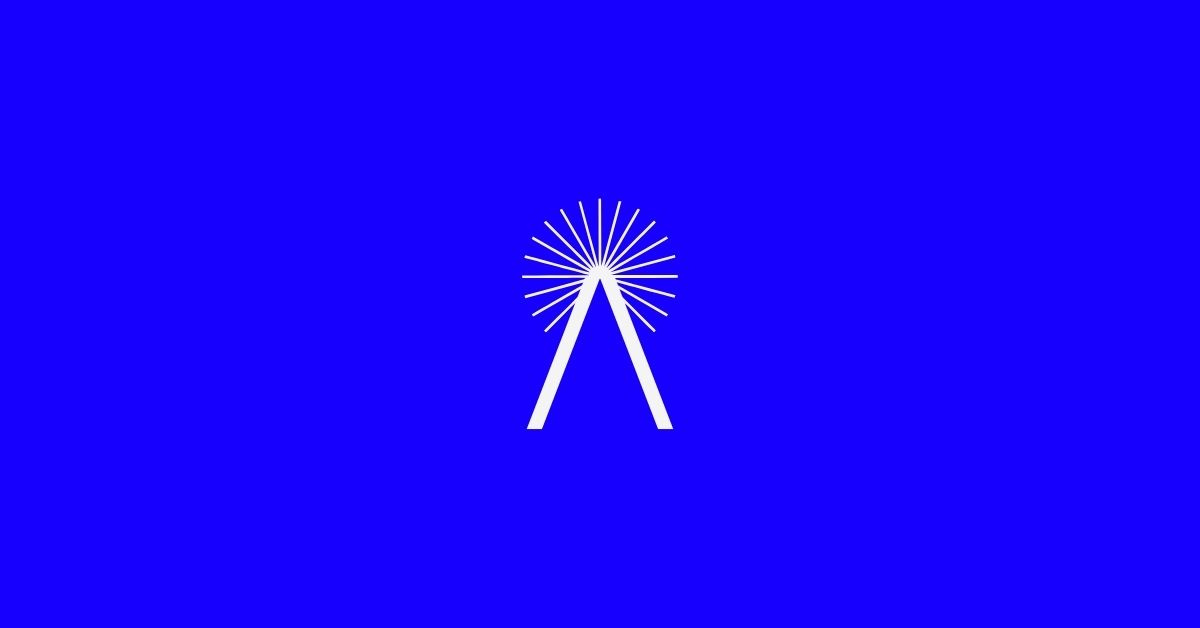Benvenut* in Presa d’aria, rubrica di poesia inedita e poetica a cura di Matteo Cristiano, Riccardo Innocenti, Dimitri Milleri e Noemi Nagy. Niccolò Bosacchi ci ha regalato quattro testi dal suo libro in via di pubblicazione Disbrigo degli affari correnti (Sensibili alle foglie), un libro che stratifica realtà diverse tra microfisica dei rapporti umani e sovradeterminazioni impersonali.
Quattro testi di Niccolò Bosacchi da Disbrigo degli affari correnti
Divaricazione dei destini individuali
Loro, dunque, quando ancora c’è una piccola promessa di comunione. Credono o mentono di essere insieme, lei piccola piccola.
Passa un anno e in loro c’è ancora una qualità di tenerezza mentre all’orizzonte si scuriscono gli eventi. Però si affaccia la paura latente. Loro stanno in città e conoscono strade e case che credono amiche: quando arrivano le prime ansie e i pensieri si fanno opachi, allora si tengono e respirano. Non basta ma possiamo dire: ora si conoscono.
Poi è inverno, quasi dolce, e loro accumulano prima anellini e braccialetti e dopo mostri terribili. Lontano si covano decisioni che però non li sfiorano, restano sospese sopra le teste, e intanto macina la produzione della vita. Affiorano cadaveri alla periferia ma loro, nonostante tutto vicini, ancora lasciano durare la sempre piccola promessa e lei sempre piccola nell’odore intimo e in altre immagini che sarebbero poi diventate un morto possesso privato. Hanno i loro luoghi, quelli dove palpitano.
La cronaca afferma che si resta di fronte a una sostanza che ha vita propria e non si lascia afferrare. Le faccende affollano i giorni e li rendono sterili. I corpi cedono, non rispondono e spesso si ammalano.
Loro, ancora, di primavera d’estate e dopo d’inverno, stanno nelle case e nei quartieri come dentro a letti sfatti, già le apparenze rovinano e rivelano il poco – lui ha i primi segni dell’ansia più nera, terribile, ridicola. L’epoca perdura esaurendosi. Un certo trasporto isterico li agita, e dopo non trovano lavoro, non capiscono.
Un’altra estate e loro vanno al mare, lei con i segni dell’ansia più nera, terribile, ridicola, e non capiscono da cosa è venuto di starsi ancora accanto fino addirittura a un nuovo inverno. E adesso invece seduti al tavolino di un bar si parlano e così finisce, in fallimento e sordo rancore. Restano poi nei mesi a venire alcuni sussulti e per qualche tempo ancora si guardano si mostrano i denti e si girano intorno. Il complesso del mondo li schiaccia, le impalcature crollano, i giornali gridano l’allarme, i prezzi rincarano, si preparano esercitazioni, inflazione e impotenza inquietano gli animi. Loro odiano tutte le strade e le case sono ostili, dell’ultima sua lui ricorda l’odore la facciata e il balcone, ma soprattutto è quella che ora lui per sempre passandoci davanti ricorderà come ultima nel loro ultimo inverno nevrotico.
Adesso si stanno lontani nella minaccia del disastro futuro, sotto il cielo di una sola eterna stagione.
[testo senza titolo]
Gioacchino da Fiore in ritardo al lavoro sottoterra sgomita sulle teste di un tranviere e una signora grassa per ottenere un cappuccino all’altezza di Gambara. Si affanna a cercare le tracce in dissolvenza di trama, porta con sé angosce a picco sulle settimane e mezzi pensieri sciacquati dalla doccia. Annota da 7 a 21 gradi e ritorno, domani forse minime in picchiata, la dottoressa alle 16.30 imperscrutabili variazioni. Tutti i frammenti si impastano alle mistificazioni, filamenti di materia che si sfarina tra le mani quando una faccia emerge in trascuratezza di occhiaie dalla nebulosa di piastrelle, acqua e sapone si intorbidano e le dita frugano la sporca intimità. Già legge autonoma della spremitura e primo dono di gemiti senza grazia, gonfiore alla pancia, immagine inaugurale dallo schermo e intanto aspetta che annuncino la ripresa della regolarità del servizio. Cercare i sintomi redigere la distinta dei volti tumefatti catalogare le forche alle quali mi sono abituato. La chiave è sul comodino all’ingresso, vicino alle bollette. Nell’aria rarefatta scorrono gli aggiornamenti di bufere, supplizi democratici o figure che deperiscono stiamo arrivando al punto di non ritorno? si susseguono rapidamente lungo decine o centinaia di giorni comunque di ghiaccio.
Romanzi d’appendice
La carne dei giorni e la morsa delle ingiunzioni, buona domenica anellette al forno palermitane, una rapina di magro bottino e condanna con patteggiamento in udienza per direttissima. Alla prima assoluta da titolare indovina un gran tiro sotto la traversa.
Immagine ormai surgelata del tuo corpo caldo e stretta di gelosia desiderio acre, cento grammi di spaghetti tempo di cottura indicato dieci minuti, rogito con valutazione del perito e dopo firma sul mutuo. Così giovane due figli piccoli e famiglia monoreddito, forti difficoltà economiche sospetta depressione.
Società degli uomini estranei, l’onesta disperazione davanti al mondo distorto, compì il delitto perché sentiva sottratta quella felicità domestica e borghese cui aveva sempre aspirato e che non aveva mai conosciuto. La sera in cui decise il massacro piovigginava ed era sola.
Vivremo bene
La città era la stessa: mercato a cielo aperto e fiera degli spettri. Però anche nel dolore per noi non c’era tenebra.
(E infatti così ingenui da bambini a pensare di cambiare il nome delle strade)
Pensare che l’albero piantato con le sue radici avrebbe aperto delle crepe. E sotto i nostri colpi, tutti insieme, sarebbe apparso il filone d’oro.
(Quando ti ho incontrata per caso che era inverno sotto i palazzi stanchi proprio dopo la nostra prima notte)
Coloro che avranno smarrito ogni ricordo, ogni memoria di essere anche luce, andranno perduti irrimediabilmente.
Ma non vale se poi diventiamo anche noi degli spettri.
Intervista a Niccolò Bosacchi a cura di Riccardo Innocenti
R. I testi che pubblichiamo oggi sono tratti da Disbrigo degli affari correnti, una raccolta che uscirà nei prossimi mesi per la casa editrice Sensibili alle foglie. Com’è nato questo libro?
N. Come spesso accade – almeno a me – è stata una combinazione di volontà e incontri. Da un lato stavano una serie di riflessioni, pensieri, appunti sparsi che cercavano di prendere una forma, tutti a stretto contatto con quello che mi capitava di vivere o di leggere. Dall’altro le discussioni continue con vari compagn* e amic*, spesso all’interno della redazione della rivista Teatro di Oklahoma di cui faccio parte, ma non solo. Tutto questo riguardava sia cosa dire che come provare a dirlo. Quindi diciamo che c’era una grossa mole di cose dietro che fermentavano e che a un certo punto hanno provato a trovare la loro strada, all’inizio in modo molto induttivo e poi via via precisandosi. Di certo c’è uno strato più immediato – o meglio, meno mediato – che è relativo alle esperienze personali e collettive e uno più mediato – o meno immediato – che viene dalle letture, da una costellazione di autori e pensatori che non sono stati importanti solo per me ma anche per situazioni più ampie di cui in vari modi mi sono trovato a fare parte. Di fatto il punto di intreccio e di sovrapposizione tra tutto questo è forse una delle vene della raccolta. Senza minimamente avere la pretesa di essere io il custode della verità di qualcosa e quindi di avere la responsabilità di restituirlo. Non per falsa modestia, ma perché non è proprio così che funziona.

R. A proposito delle vene della raccolta, mi pare di riconoscere nelle atmosfere che descrivi, nelle inquadrature che proponi, la città di Milano. Che peso ha avuto sulla tua scrittura il luogo in cui vivi?
N. Credo molto grande. Milano è la città dove sono nato e anche l’unica in cui ho vissuto, quindi anzi è forse una di quelle cose che stanno troppo vicino agli occhi per vederle bene. Parlandone temo che mi si addensino tante cose diverse. Milano è una città ovviamente ricca, forse l’unica metropoli in Italia. È la città dove si respirano i flussi di denaro reale o immaginario, che si danna l’anima per apparire come un centro propulsivo e fagocita senza pietà i propri quartieri, cresce speculando su se stessa. Si avvia a diventare letteralmente invivibile, sempre più cara, sempre più intangibile. Quasi nessuno dei suoi abitanti può sentirsi al riparo, tutti devono domandarsi in qualche modo se potranno ancora effettivamente restare lì. E questo anche solo guardando chi fa parte della fascia che ha da un punto di vista economico e politico ha un teorico diritto di cittadinanza. Poi, dappertutto, ci sono i fantasmi (da questo punto di vista noto di passaggio i due luoghi di tortura nascosti che Milano si tiene all’interno del proprio tessuto urbano, il carcere di san Vittore che è addirittura in centro e il CIE di via Corelli, più in periferia ma comunque in città). Quindi vivendo in una città del genere la percezione di scarsa consistenza di sé e di sostituibilità è qualcosa di più di una tonalità emotiva. Poi, e sembra contraddittorio ma è così, è al tempo stesso una città che vuole apparire ricca ma in realtà è povera, e che alleva ampi strati di abitanti che di fatto sono – prendendo a prestito un bellissimo verso di Giorgio Cesarano – una semi-razza di liberti, di schiavi liberati. Milano si mostra grande ma è anche urbanisticamente in fondo piccolina, e se si fa un passo indietro ci si rende conto che è una metropoli, sì, ma periferica in una nazione periferica all’interno di un continente che probabilmente si avvia a diventare periferico. Insomma, è un buon posto per sentirsi all’interno di un processo enorme e assolutamente ininfluenti. Poi certo, bisognerebbe capire com’è possibile che a una materia tanto nera si impastino le varie esperienze che sono, effettivamente a volte, anche momenti di gioia. Come si può stare in un luogo inabitabile e volerlo abitare, dove vadano a finire le forze che una città piega o fagocita ma che ciononostante anche in forme infinitesimali appaiono, e per necessità di sopravvivere tendono poi a prendere la forma del posto in cui stanno e che magari anche odiano, quindi Milano in questo caso.
R. Dei tuoi testi ciò che più mi ha colpito è il fatto che intercettano la dimensione sovraindividuale dell’esistenza restituendo la microfisica dei rapporti umani e le forze che li determinano. Nel mondo che descrivi attraverso prospettive a tratti impersonali, dall’alto, tutto ciò che è umano e biologico sembra ridotto a un fattore residuale. Lo sguardo, non privo di un’ironia amara, è quello di un fotografo compiaciuto o quello di chi cerca di comprendere?
N. Sicuramente non quello di un fotografo compiaciuto, o perlomeno non è quella l’intenzione. Proviamo a metterla così, che poi è più un punto provvisorio che un risultato di arrivo: da un lato la dimensione sovraindividuale – usiamo un macrotermine pieno di insidie: la politica – non può che essere intessuta di tutte le forze di vita dei rapporti concreti, e quindi delle traiettorie di esistenze singole. Ma non l’ho certo detto io per primo. Dall’altro proprio questo mette di fronte a uno scacco grande, sia perché il complesso del mondo e della storia è ben più ampio e soprattutto straordinariamente distante e soverchiante rispetto a una singola esperienza sia perché a un certo punto le singole esperienze nelle quali si rifrangono i rapporti del mondo diventano un muro o un possesso privato, quindi inaridito. Non credo di aver risolto nulla di tutto ciò scrivendo, ma per me se c’è un punto di partenza è questo, tutti quei momenti dove il residuo appare, in modo di gioia quanto di dolore. C’è una concretezza di vita che è un incrocio di queste contraddizioni e non è assolutamente autentica (a me non piace per nulla questo termine) ma anche nel suo essere tutta piena del falso – del falso del mondo, del falso dei rapporti, del falso delle mistificazioni – ha dentro di sé qualcosa che potrebbe essere servibile. E può servire non perché dia una risposta su come finisce la storia quanto più aiuta nello sforzo di leggerla. Di fatto è scrivere per provare a capire. Volendo cercare un punto di riferimento — ma è lanciare altissimo — un concetto che ho sempre considerato straordinario è quello delle immagini di pensiero di Walter Benjamin. Non per istituire un termine di paragone rispetto a ciò che scrivo (direi che ne siamo ben lontani) ma perché il rapporto tra il pensiero e l’immagine che si presenta – soprattutto se è un’immagine micologica, per usare una bella espressione di Adorno una piccola “cellula di realtà”, è una chiave che trovo interessantissima. Anche qui sono consapevole che non è nulla di nuovo né una strada inesplorata, ma questo non mi toglie il sonno.

R. Quindi la tua scrittura sarebbe un tentativo di afferrare questa “concretezza di vita”, eventualmente discernendo ciò che è “servibile” da ciò che è “falso”? Pensi che attraverso questo processo la letteratura possa incidere sulla realtà?
N. Qui si apre uno squarcio enorme. Provo a balbettare la mia parte: in assoluto probabilmente no. Penso alla prima pagina della Teoria del romanzo di Lukàcs dove si dice che nei tempi beati si può presumere che tutti siano filosofi o poeti, il che significa che non ci sono filosofi o poeti. Quindi sullo sfondo resta, per quanto possa suonare fuori moda, il vecchio motivo della divisione del lavoro, e del fatto che vengono sempre prima le cose dall’altro lato del foglio e queste, semmai, producono la loro letteratura quando ne sentono il bisogno. Non so se ci sia stato un mandato in passato – se lo chiedevano quando la questione aveva ben altro peso – e quindi tantomeno posso dire se ci sia adesso, so per certo che nessuno lo ha dato a me. Però allo stesso tempo mi pare che un certo cilicio e autofustigazione sulla nullità della letteratura da parte di chi scrive sia – anche in buona fede – un autoinganno per continuare a farne. Una sorta di gioco delle tre carte che ci si fa da soli: una mano mostra la carta “le cose importanti sono a libro chiuso” così l’altra nel frattempo scrive i libri. A questo punto forse è meglio prendere con onestà le mosse dal posto in cui si sta. E quindi – ma di nuovo, è una cosa provvisoria – si può provare a pensare di scrivere rivolti a qualcuno. Che non è scrivere per, che si porta dietro l’idea di “a nome di” o anche la certezza di avere qualcosa da comunicare. Ha però dentro di sé lo sforzo di articolare: articolare una voce o un discorso, o forse meglio ancora articolare la richiesta di una voce o di un discorso, e farlo di fronte a un interlocutore, consapevoli dello spazio e del codice limitato che si è scelti. I codici restano pietrificati, ma intonare geremiadi su questo non li scioglierà. Le rotture se arriveranno non arriveranno da dentro i testi, è tutto ancora ben lontano dall’incidenza sulle cose e ancora meno garanzia di qualità o rilevanza di ciò che si scrive. Ma forse non è del tutto vano. O di nuovo, è un falso con qualcosa di servibile.

Niccolò Bosacchi è nato nel 1990 a Segrate. È laureato in filosofia e lavora come insegnante, ha fondato insieme ad altr* la rivista Teatro di Oklahoma