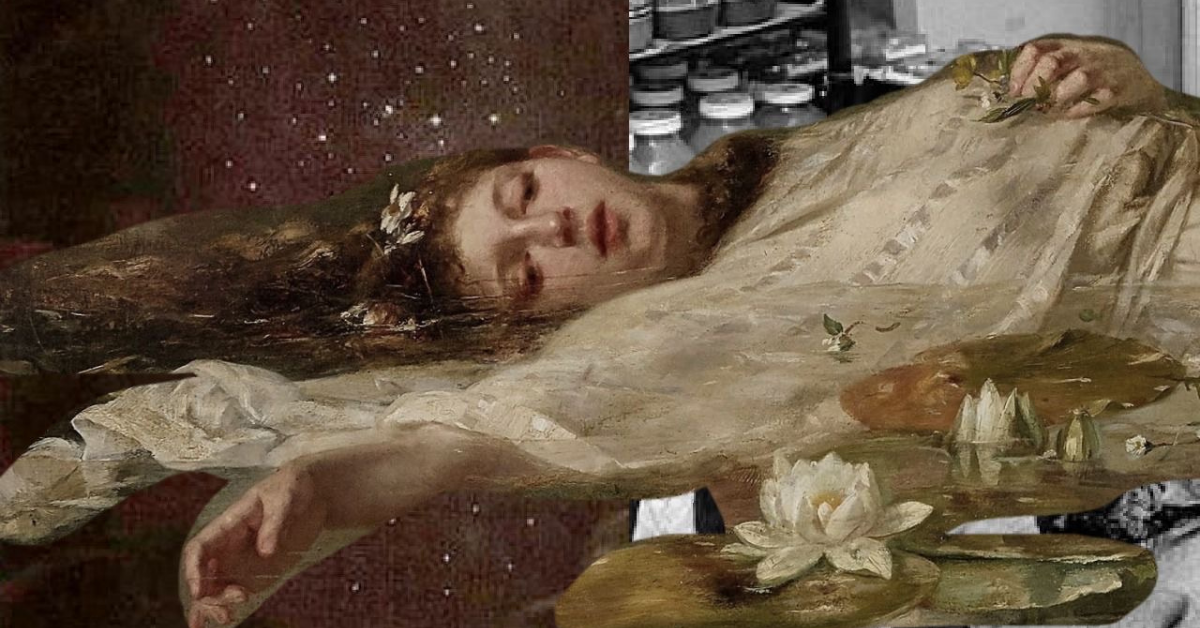Anche quando ne intravedo limiti ed eccessi, la poesia latina del Rinascimento continua a esercitare su di me uno strano ascendente. Leggo le Neniae di Pontano, l’Epicedion in Albieram di Poliziano, le Eclogae Piscatoriae di Sannazaro come fossero gialli a enigma e dovessi trovarne la chiave, nascosta dietro una rete immensa di riferimenti intertestuali.
Il vero rebus di questa letteratura, ricchissima e ingiustamente negletta, è iscritto nella lingua stessa: un latino letterario tirato a lucido, che a me pare irriducibile alla mera retorica di scuola, tanto è diversificata la comunità letteraria che lo adotta. Più vado avanti con le letture, più intuisco che l’aria di famiglia determinata dall’uso di una lingua morta e di una retorica comune è un’illusione. A viziare occasionalmente la mia fruizione estetica non è la presunta monotonia dei testi, ma l’altro codice, quello che struttura la mia esperienza di lettore del ventunesimo secolo, poco allenato a esercitare la memoria letteraria e a visualizzare immagini ormai canonizzate.
In questa rubrica, Neolatina, proverò a rimettere in circolo testi ignoti o poco noti ripensandoli dall’interno. La traduzione metrica qui riportata va in questa direzione: gli esametri sono trasposti in versi di quindici sillabe, i pentametri in alessandrini costituiti generalmente da settenari piani. L’intento è quello di mimare l’eleganza dell’originale senza cristallizzarne la vivacità.
Bazzicando la letteratura del Quattrocento, non è raro imbattersi in opere singolari come il Liber Isottaeus, raccolta di epistole in versi attribuite a Basinio di Parma, il massimo poeta latino della Rimini cortigiana. Caratterizzato da una struttura polifonica, l’Isottaeus dà voce a Sigismondo Pandolfo Malatesta (1417-1468), signore di Rimini, e a Isotta degli Atti (1432 ca – 1464), sua amante e poi moglie, nonché al poeta stesso e al padre di Isotta: ripercorrendo la storia d’amore dei protagonisti fino alla malattia e alla morte della ragazza, i quattro personaggi ci parlano da un mondo artificiale, chiuso nella propria bellezza, ma anche permeabile al lutto e al dolore.
Nell’elegia qui proposta, la nona del primo libro, Sigismondo è visitato in sogno dal fantasma di Isotta, che gli annuncia di essere malata. Pur essendo ancora viva, Isotta è già nel dominio dei «lemures» (v. 4), «le anime dei silenziosi» («animas […] silentum», secondo la definizione che ne dà Ovidio in Fast. V, 483): basta il presagio della morte a scarnificarla, facendone una creatura nebulosa, adatta all’elegia.
Dopo la visita onirica del fantasma Sigismondo salta giù dal letto e apre le finestre per far entrare la luce: è mattina; l’ora denota che il sogno è verace. Intorno a lui si affollano altri segni premonitori che investono la natura e ne alterano i cicli, al punto che il sole si dice indistinguibile dalla luna (v. 20); sopraggiunge un messo che conferma la fondatezza del sogno (vv. 26-27: «Pende a un filo la vita della ragazza che ami: / la febbre la tormenta con accessi dolorosi»). La seconda parte della poesia si intride conseguentemente dei toni del lamento e della preghiera.
Poeti e teorici dell’onirocritica, da Omero a Gerolamo Cardano, categorizzavano i sogni secondo l’origine, fisiologica e divina, e alla natura, verace o fallace. Macrobio annovera tra i sogni veraci l’oraculum, il somnium e la visio. Nei versi di Dante e Petrarca ricorre l’idea che i sogni dell’alba siano veri (Inf., XXVI, v. 7: «presso al mattin del ver si sogna»; e RVF, 33); la stessa idea è presente nell’Isottaeus, dove quello che in termini psicoanalitici si potrebbe classificare come un «sogno d’angoscia» corrisponde perfettamente alla descrizione dei «sogni terribili» di Cardano nei Sogni (II, 9, trad. Montiglio e Greco):
Se i sogni terribili non provengono invece dal cibo, senza dubbio segnalano la minaccia di gravi mali. […] E vi sono più generi di immagini terribili; le peggiori sono quelle che fanno balzare l’uomo dal letto, perché sono sempre nefaste; quindi quelle che lo spingono ad alzarsi, e da ultimo quelle che lo portano a sudare. Quelle che non arrivano a suscitare codesti effetti non sono poi così funeste. […] Sono sogni terribili tutti quelli che preannunciano qualche grande male. E grandi mali sono la propria morte o quella dei propri cari.
Per la sua natura ominosa e terribile, il fantasma di Isotta ricorda creazioni poetiche ottocentesche come la Lenore del Corvo di Poe e la donna defunta del Sogno di Leopardi, altro testo in cui si concede ampio spazio al dato luministico (cfr. vv. 1-3: «Era il mattino e tra le chiuse imposte / Per lo balcone insinuava il sole / Nella mia cieca stanza il primo albore» e vv. 99-100: «e nell’incerto raggio / Del Sol vederla io mi credeva ancora»).
L’Isotta del Liber è insieme diversa e uguale alle altre muse della poesia quattrocentesca: primattrice del dramma quando l’autore assume il suo punto di vista, tanto più viva e presente sulla scena quanto più è distante dall’amato Sigismondo, torna a ricoprirsi di una patina di fissità non appena il poeta cambia le lenti della focalizzazione. In queste vesti compare anche nell’elegia I, 9, bella e intatta anche nell’aegritudo: un’illusione dei sensi, platonicamente vera in rapporto al suo grado di idealizzazione.
Anche altrove Isotta è più simile a uno spettro che a una donna in carne e ossa: così in III, 4, quando balena ingannevolmente tra la folla durante il trionfo di Sigismondo. Sarà proprio il terzo libro a completare la sua trasformazione in pura effigie, successiva alla morte: un evento tutto letterario, quest’ultimo, perché la vera Isotta sopravvive ben oltre il tempo del racconto, e destinato a congelarla per sempre nella posa in cui l’ha colta il medaglista Matteo de’ Pasti (cfr. III, 9, vv. 95-96: «E venga, come un tempo, coi capelli pettinati, / quale sul bronzo è colta da una mano d’artista»; «Et veniat cultis, ut quondam, culta capillis, / Daedalia facta est qualis in aere manu»).

Sigismundus Pandulphus Mal. divae Isottae Ariminensi salutem dicit
Quis neget eventus portendere somnia veros?
Praescia venturi quis neget illa mali?
Quis sine processu neget apparere maligno
Luctiferos nocte concubia Lemures?
Languida iam nuper dederam mea membra quieti,
Quom late somno corpora fessa silent,
Iamque emensa suum cursu breviore laborem
Luna revertentem fugerat alba diem:
Ecce mihi visa es fusis astare capillis
Livida vix tollens lumina tristis humo,
Discolor et nulli credenda Isotta; sed aegra
Et quanvis esses pallida, pulchra tamen.
Et prior «o» dixti «carae succurre puellae,
O vitae, princeps, maxima cura meae!»
Protinus exurgo turbatus pectore toto,
Nam facile credit quae timet omnis amans.
Admitto lucem, iam lux erat orta, fenestris:
Hei mihi non solitis lux erat illa modis!
Caligoque polum totumque obsederat axem;
Sol erat, ut dubites lunane solne foret.
Nec sacer horrendo compescuit omine vocem
Praesagam tanti corvus ab arce mali.
Vix erat instantis pars sexta exacta die, cum
Tristis adest cladis nuncius ecce meae
Et vix haec nobis lacrymis expressit abortis:
«In dubio vitae pene puella tua est;
Febris enim vicibus moribundam torquet amaris
Scilicet et toto pectore flamma furit».
Quid poterat dempta mihi tristius addere morte?
Mors etiam potuit fellis habere minus.
Heu heu quos gemitus, heu quae suspiria nobis,
Heu quos singultus attulit illa dies!
Quid facerem? Pacto poteram te visere nullo,
Nec poteram vultus ire videre tuos;
Regis enim Alphonsi felicia dum sequor arma,
Non potui patriae regna videre meae.
Et quoniam, ni fallor, erit mihi tardior istuc
Accessus, fungar qua datur aeger ope.
Absentem pro me te viset epistula saltem,
Littera sermonis nuncia fida mei.
Quod iam, si qua meae spes est tibi certa salutis,
Te precor o, si quid te benefacta iuvant,
Restitui primae cura te, Isotta, saluti;
Effice quo valeas, cara puella, rogo,
Itala ne tanta tellus privetur alumna,
Cuius non habuit, non habet illa parem;
Neu commune decus fleat omnis Isauria, neve
Urbis Arimineae gloria tanta ruat.
Tu quoque, cui medicas invidit Iupiter artes,
De secto matris ventre revulse puer,
Ipse fave et nostrae tandem succurre puellae;
Tuque adhibe medicas, Phoebe superbe, manus.
Sigismondo Pandolfo Malatesta saluta la divina Isotta da Rimini
Chi negherà che è vero ciò che i sogni presagiscono?
del male che è alle porte chi mai li dirà ignari?
Chi negherà che lemuri dolenti a notte appaiano
con passo non maligno, nel tempo che si dorme?
Avevo appena reso al sonno il corpo intorpidito,
quando un silenzio esteso fanno dormendo i corpi,
e già condotto a termine il travaglio, in corsa rapida –
tornava il giorno – bianca la luna lo fuggiva;
quand’ecco, mi sei apparsa: in piedi, coi capelli sciolti,
tetra: levavi a stento da terra gli occhi lividi,
trascolorata – chi ti avrebbe mai creduta Isotta? –
ma bella, benché preda del morbo e del pallore;
e «ahimè» parlasti tu per prima «da’ soccorso – o principe,
cura della mia vita – alla ragazza che ami».
Salto in piedi all’istante, con il cuore sottosopra:
prende ogni amante il proprio sospetto per realtà.
Lascio filtrare il giorno – è l’alba, ormai – dalle finestre;
ahimè, che strano modo di sorgere, quel giorno!
Una foschia teneva sotto assedio il cielo intero;
il sole non capivi se fosse sole o luna;
né dalla rocca soffocava il corvo abominevole
il suo verso, tremendo presagio di disgrazia;
del giorno era conclusa ormai la sesta parte, quando
lugubre – ecco – un corriere mi annuncia la sciagura,
a stento pronunciando tra le lacrime il messaggio:
«Pende a un filo la vita della ragazza che ami:
la febbre la tormenta con accessi dolorosi;
quasi ne muore; in petto le impazzano le fiamme»;
fuorché la morte cosa avrebbe aggiunto di più triste?
forse sarebbe anch’essa suonata meno amara.
Quali lamenti mi ha recato, ahimè, quali sospiri
quel giorno destinato! ahimè, quali singhiozzi!
Che cosa avrei dovuto fare? Non potevo certo
visitarti, venire da te, vederti in viso;
infatti, mentre vado dietro alle armi fortunate
del re Alfonso, non posso tornare ai regni patrii;
e poiché, se non sbaglio, non ti sarò accanto a breve
non trovo, me infelice!, altro mezzo che questo.
Al posto mio lontano ti riveda almeno questa
lettera, messaggera fida del mio discorso;
ché, se nutri speranza di salvarmi, ti scongiuro,
o se i favori resi valgono mai qualcosa,
sforzati, Isotta, di recuperare le tue forze;
prego che ti rimetta, mia cara, e che non venga
meno alle terre italiche una simile fanciulla;
non ebbe mai, non ha al momento chi ti eguagli:
non pianga tutta Isauria un lutto pubblico, non crolli
una simile gloria della città di Rimini;
e tu, cui Giove invidiò le arti mediche, fanciullo
strappato un giorno al ventre reciso della madre,
sii buono e da’ soccorso alla ragazza che amo; Febo
glorioso, le tue mani le diano la salute.