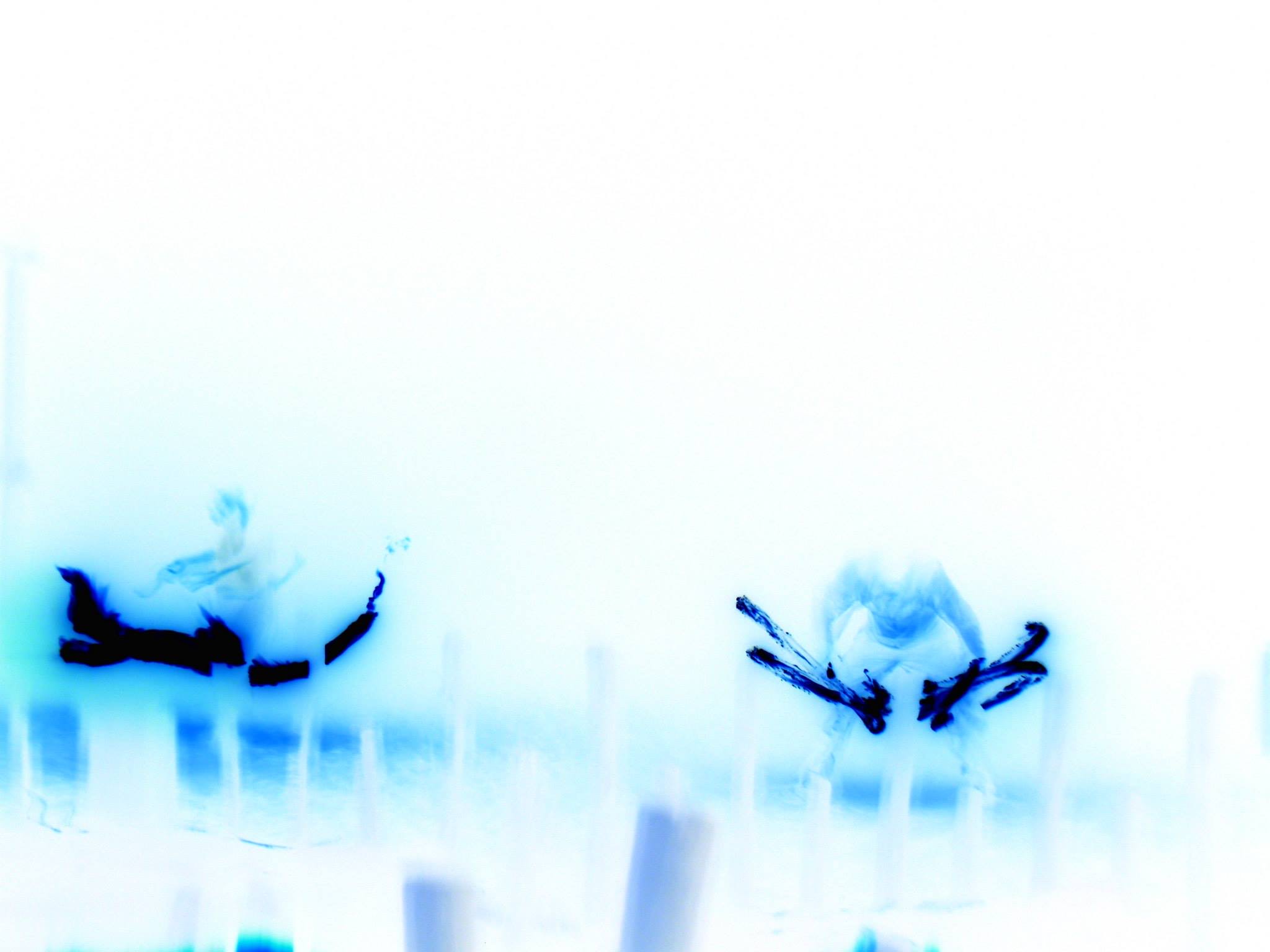Quello che so della fabbrica è dovuto agli scritti di Marx ed Engels, allo studio delle lotte operaie italiane ed europee dal biennio rosso in poi, e ai film di Elio Petri. Perciò della fabbrica non so nulla, ma quando ho sentito parlare per la prima volta Dario Salvetti, RSU Fiom e delegato della GKN, ho sentito che parlava anche di me e per me, lavoratrice senza diritti, licenziata da un giorno all’altro con gli sms, ricattabile, senza aver mai avuto ferie pagate, malattia retribuita, diritto di sciopero. E parlava anche della mia comunità, del mio mondo: ecologico, antispecista, antirazzista, transfemminista, solidale, cooperativo. Ma facciamo un passo indietro per capire perché.
La scoperta della poesia
Quando ho scoperto che Majakovskij all’inizio buttava le sue poesie perché si vergognava di praticare un’arte borghese, ero ancora nella bambagia della scuola pubblica gratuita italiana e della rete delle biblioteche comunali, dove anche una figlia della classe subalterna può entrare a mettere su massa intellettuale, a imparare i giochi linguistici dei dominanti, a scoprire la filosofia e la poesia.
La scoperta della poesia (della poesia borghese, quando non nobiliare, della poesia scritta da maschi, della poesia scritta da bianchi, del canone della poesia occidentale che mi si poneva come il canone mondiale e universale, come la Poesia con la P maiuscola e senza aggettivi) ha sabotato per molto tempo altre scoperte, facendo da tappo e da strumento di indottrinamento, sequestrandomi in un mix di romanticismo e capitalismo: passioni tristi, esistenzialismo, pessimismo cosmico, solipsismo, nichilismo, disillusione, esaltazione del genio individuale, distinzione sociale rispetto alla massa o ai miei pari, verso cui mi sentivo superiore, migliore. Infatti scrivevo poesie orrende e inutili, iper-espressiviste, fondate sul mito del poeta dotato di privilegi epistemologici, che esprime la sua interiorità, le sue riflessioni sul mondo, la sua esperienza extra-ordinaria in un testo che si pone sia come equivalente simbolico della sua estraneità al mondo, sia come forma verbale del vero. Il mito del poeta romantico è intrecciato all’individualismo capitalista e viene da esso implementato nei suoi ritornelli imperativi: lavora, produci, acquista, consuma, esprimiti, distinguiti, godi. Insomma, nella mia adolescenza la poesia è stata la cassa di risonanza del capitalismo. Ero un’io senza noi (ovviamente non lo ero, nessunə lo è, ma mi ci sentivo), chiusa in me, nelle mie poesie, in quelle dei morti, nei miei traumi infantili, nei miei drammi familiari, in un fiero titanismo.
Le tonalità emotive capitalistiche, come opportunismo, paura, odio, cinismo, disincanto, impotenza, hanno siglato la moralità e gli stili di comportamento delle forme di vita prodotte dalla controrivoluzione neoliberale dispiegata dagli anni Ottanta/Novanta in poi, nella cuspide incarnata da Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Sempre partendo dal presupposto dell’intreccio agerarchico tra struttura socio-economica e sovrastruttura simbolico-spirituale, quei sentimenti vengono poi sussunti e diventano requisiti professionali, skills da mostrare ai colloqui e nelle giornate lavorative, ma anche fuori, innervano il tempo della vita e della letteratura. Un paio di anticorpi per fortuna li ho ricevuti dall’educazione di mio padre, riottoso a qualsiasi forma di ambizione, hippie con la terza media e col mito del ‘68, che mi ha insegnato a rubare nei supermercati, non citando Marx ma De Gregori (Tu da che parte stai? Stai dalla parte di chi ruba nei supermercati? O di chi li ha costruiti, rubando?) e che con il calcio mi ha inoculato spore del pensiero che anni dopo avrei scoperto nei Subaltern & Decolonial studies: infatti ad ogni partita di calcio si tifava per la squadra più debole, e ai mondiali per qualsiasi squadra africana. L’antilavorismo di mio padre ha contribuito alla povertà della nostra famiglia: ha lavorato come postino per 10 anni, dalle 7 alle 14 e si è sempre rifiutato di trovare un secondo lavoro pomeridiano o serale, preferendo fare la pennica, passeggiare in spiaggia, leggere libri, sfogliare il dizionario della lingua italiana, pedalare chilometri in bicicletta. Quando mi lamentavo per il frigo vuoto mi rispondeva se ti dirà bene nella vita sarà magnifico, ma se ti dirà male sarai preparata. Quando mia madre ha iniziato a ricevere la pensione di disabilità, le cose sono andate tutto sommato meglio economicamente, così da permettermi di non lavorare almeno durante i primi anni di università. Quando mio padre è stato licenziato, le cose sono tornate difficili.

La scoperta del conflitto
Poi è arrivato il 2001: George W. Bush, Berlusconi, la rivoluzione zapatista, Porto Alegre, Seattle, Nizza, Praga, ma soprattutto il G8 di Genova. L’assassinio di Carlo Giuliani, la Diaz, lo sconcerto, l’indignazione. Non c’ero fisicamente perché troppo piccola, ma credo sia stata la prima volta che ho sentito una rabbia furente non privata, credo la prima volta che mi sono sentita toccata perché avevano toccato, picchiato, manganellato, torturato, ucciso qualcun’altrə, tantə altrə.
Dopo poco la guerra in Afghanistan, l’operazione enduring freedom, l’esportazione della democrazia, la guerra in Iraq, Abu Ghraib, lo sconcerto, l’indignazione. Durante una manifestazione nazionale contro la guerra, per rispondere alle cariche violentissime della polizia, il mio fiero titanismo ha lanciato la sua prima bottiglia da 66 contro le guardie. Ho iniziato a scrivere poesie che non parlavano solo di me. I tomi di poesia che compulsavo furono sostituiti dallo studio della storia e delle ingiustizie in corso nel mondo, dall’informazione costante.
La mia militanza, il mio spirito antagonista stava diventato corposo proprio nel momento della repressione e della sconfitta del movimento globale; delle sue rotture dell’ordine pubblico; del suo ethos alternativo a quello vigente organizzato secondo le categorie di sfruttamento, profitto, denaro, merce, spettacolo; della forza-lavoro moltitudinaria che voleva cominciare qualcosa di nuovo e prendere la parola. Non a caso, questi ultimi sono i due tratti peculiari della prassi politica secondo Hannah Arendt in Vita activa.
Poi è arrivato il 2008 e l’Onda, il movimento nato a partire dai tagli all’istruzione varati dal governo Berlusconi nel 2008, confluiti poi nella catastrofica legge Gelmini approvata il 29 ottobre del 2010, che ha contribuito alla privatizzazione dell’istruzione pubblica e della formazione della classe docente, alla precarizzazione della ricerca e dell’insegnamento, all’aumento dei tassi di dispersione scolastica, alla chiusura di molti istituti, alle classi che superano i 25 studenti. Allora non sapevo ancora che 12 anni dopo a scuola ci sarei tornata nei panni di insegnante e che avrei sofferto anche sulla mia pelle quell’opera di distruzione di un pezzo di welfare.

La scoperta del lavoro salariato
Tre anni fa Annalisa Camilli ha scritto e registrato il podcast Limoni per ricordare e raccontare quello che è successo a Genova, durante quella che è stata definita la più grande sospensione dei diritti democratici in un Paese occidentale dopo la Seconda guerra mondiale. L’ho ascoltato piangendo, mentre andavo a lavoro. Avevo iniziato a lavorare già durante l’università, sapendo che non avrei mai potuto smettere. All’inizio con qualche lavoretto, poi dovendone comporre una gamma varia per poter arrivare a un reddito che mi permettesse di sopravvivere in una città come Roma. Per 10 anni sono riuscita a guadagnare 800 euro al mese, spendendone 500 di affitto e spese. Si può fare, se non si hanno nevrosi borghesi, ma lo si fa soprattutto se si è ricattabili.
Ho svolto principalmente due tipi di lavoro: il primo come cameriera, soprattutto nel periodo estivo, ogni anno in posti differenti, senza contratto, senza diritti, senza tutele, con un salario orario che è oscillato tra i 4,5 e 5 euro l’ora, con picchi di 7,5 euro l’ora. Dal 2015 al 2020 non sono mai partita in vacanza d’estate, perché ho sempre lavorato, né d’inverno, perché non avevo i soldi. Dal pub a Centocelle sono stata licenziata perché non potevano permetterselo. Dal pub a Garbatella mi sono licenziata perché non mi pagavano da mesi. Dal centralino presso una scuola di lingue mi sono licenziata perché ero costretta a sorridere costantemente e perché mi mettevano un’assurda ansia produttivista. Dal bistrot a via del Governo Vecchio sono stata licenziata perché mi ero presa la rosolia ed ero dovuta rimanere un mese a casa. Dal bistrot a Trastevere mi sono licenziata perché dovevo essere ubiqua, stare sia in sala che in cucina, dare una mano ovunque servisse. Dalla pizzeria in viale Tirreno sono stata licenziata perché avevo avuto un incidente stradale e una prognosi di almeno un mese di riposo e fisioterapia. Dalla pizzeria a Centocelle mi sono licenziata perché un mio collega mi aveva toccato il culo e tutti si erano messi a ridere divertiti, trattandomi da isterica esagerata che non sa soprassedere. Dall’enoteca vicino piazza Navona mi hanno licenziata perchè ho osato farmi venire la faringite con febbre di SABATO. Dal ristorante in via del Pigneto sono stata licenziata perché un ragazzo di un istituto alberghiero, grazie all’alternanza scuola-lavoro varata nel 2015 dal governo Renzi (prima o poi appenderemo anche lui a testa in giù), mi ha sostituito facendo i miei turni, ma gratis. Tuttavia, anche se non mi avessero licenziato loro, probabilmente me ne sarei andata via io, perché il carico di lavoro era talmente estremo che dovevo imbottirmi di ibuprofene per finire il turno (l’incidente del 2009 si faceva sempre più sentire), mentre i miei colleghi, ben più giovani di me, tiravano coca spendendo anche 35 euro, a fronte di 45 euro di salario per 9 ore di lavoro. Cercavo di far notare l’assurdità di tutto ciò quando staccavamo, quando alla coca subentrava l’alcol e la cannabis per rilassarsi e dimenticare quello che ci avevano fatto, quello che ci avevano tolto. Il sabato sera il locale incassava una media di 50.000 euro. Una volta, in 5 ore di turno pagate 25 euro, ho portato a un tavolo un conto di 2500 euro. Dal ristorante al Quarticciolo sono stata licenziata perchè ho chiesto un aumento del salario, ma nel poco tempo che sono stata lì sono riuscita a convincere K., la cuoca sfruttata ben più di me, che non protestava perché a 55 anni con un ginocchio sfondato dove vado? chi mi prende?, a fare vertenza anche lei, promettendole che le avrei fatto da testimone. Sì, perché in una vertenza avere dei testimoni è essenziale per la forza-lavoro ed è anche la cosa più difficile da rimediare per omertà, viltà, conformismo, paura, servitù volontaria, sindrome di stoccolma, impoliticità diffusa. Grazie alle CLAP (Camere del Lavoro Autonomo e Precario) e ai loro avvocati civilisti che mi hanno seguito pro bono, ho fatto vertenza agli ultimi due ristoranti che mi avevano assunto in nero e che mi avevano licenziato con un messaggio su Whatapp, chiudendo così per sempre la mia relazione con il mondo della ristorazione. Così mi è rimasto solo il secondo lavoro ed è iniziato il periodo di autoschiavismo: da ottobre a maggio dovevo guadagnare molto di più per poterne ricavare l’affitto dei mesi estivi. Sono arrivata a guadagnare 2000 euro a maggio, per poterli spalmare su luglio e agosto. Ero nel pieno di quello che poi ho definito esaurimento nervoso da mancanza di reddito.
In tutto ciò non ho mai smesso di scrivere, ma quando scrivevo non ho mai parlato di lavoro, delle condizioni materiali in cui vivevo, delle difficoltà, degli esaurimenti, dell’ibuprofene. D’altronde la poesia che avevo letto e che leggevo, di lavoro non parlava. Inoltre, quando avevo conosciuto le poete e i poeti contemporanei e avevo scoperto che la maggioranza non lavorava proprio o lavorava a scuola, ma aveva ovviamente casa di proprietà in città come Roma o Milano. Per anni, quando mi sono ritrovata alle cene post-presentazione dei libri di poesia, mi sono sempre fatta pagare la cena da un poeta proprietario o da uno più abbiente di me e incline al senso di colpa. Per anni, un pezzettino del sistema della cultura e della poesia italiana si è fondato anche sullo sfruttamento del mio giovanile entusiasmo, che mi ha portato a curare 2 festival di poesia e arti sperimentali, varie edizioni di laboratori di scrittura, scrivere 7 libri di poesia e 8 saggi critico-filosofici, senza essere mai retribuita per il mio tempo e il mio lavoro, che comunque ritagliavo con fatica dal tempo che mi avanzava, dopo che avevo espletato gli altri lavori con i quali riproducevo la mia forza-lavoro. Ho sempre voluto scrivere un libro di teoria e critica letteraria, ma in quale tempo? Il sistema è truccato: come fare a raggiungere gli stessi risultati, leggere la stessa quantità di libri, scrivere la stessa quantità di saggi e recensioni, farsi gli stessi contatti, acquisire le stesse conoscenze e competenze, curare la stessa quantità di collane, festival, antologie, ecc., di chi viene mantenuto dai genitori? di chi può fare lo stage non retribuito in casa editrice? di chi può pagarsi le trasferte e i pernottamenti per le presentazioni dei libri in giro per l’Italia? di chi non deve pagare l’affitto per sempre? di chi non deve buttare 9 ore al giorno per servire pizze e pulire cessi? Alla fine il braccio di ferro del capitale ti stanca, ti schiaccia e, se molli, non dipende da quanto entusiasmo o spirito del sacrificio o talento hai. Dipende dalla classe. Nessunə se ne accorge se molli, sia perché la maggioranza delle persone dell’ambiente appartiene alla classe borghese, sia perché si sa che solo unə su mille ce la fa, sia perché il sistema culturale ti sostituirà con centinaia di altrə giovani dispostə a lavorare gratis per un po’ o per sempre, e così via nel tritacarne del capitalismo. Una volta ho fatto la babysitter ai figli di una nota poeta e romanziera con casa di proprietà a Roma. I figli dicevano: mia madre fa la poetessa. Io li correggevo: se potete dire che come lavoro vostra madre fa la poetessa, vuol dire che è ricca.
E tuttavia sono stata fortunata: ho usufruito dei rimasugli dello stato sociale edificato 60 anni fa, che mi ha permesso di essere la prima laureata della mia famiglia. Proprio quest’anno ho preso anche una seconda laurea in filosofia (sul pensiero della democrazia in Marx), grazie a chi ha lottato per la progressività delle tasse universitarie e così io, con il mio reddito, ho pagato 150 euro l’anno. Poi, se leggi i libri giusti, capisci che se quando parli di un diritto usi la parola fortuna, allora è di un privilegio che stai parlando: il privilegio di aver studiato quasi gratis, il privilegio di aver trovato lavoro perché bianca, italiana e con corpo conforme, il privilegio di essere nata in un paese dell’Occidente e cresciuta in una sua capitale.
Di più: il sistema oltre a truccare i destini, manomette le coscienze, i desideri, le pratiche. Se si pensa che non possa essere abbattuto, se si vive con il costante terrore di restare o di finire a lavare i cessi, l’unica alternativa è identificarsi nella competizione, nell’indifferenza e diffidenza, sperando di ottenere questo agognato capitale simbolico culturale con cui poi, se non hai già proprietà e rendita, non ci fai assolutamente nulla, a meno che non provi la via del romanzo.

La scoperta delle case delle classi dominanti
Il secondo lavoro, come dicevo, che ho svolto è stato quello di istitutrice/educatrice/insegnante privata, senza contratto ovviamente, per le figlie e i figli delle famiglie bene di Roma, da ottobre a maggio ogni anno dal 2012 al 2020, nel tempo formandomi e specializzandomi nella didattica per ragazze e ragazzi con disturbi dell’apprendimento. Ero entrata perciò a far parte dell’universo classista delle ripetizioni, che invece di rimuovere gli ostacoli socio-economici, come detterebbe l’articolo 3 della Costituzione italiana, li riproduce, li amplifica, li fortifica. Durante il covid ho fatto ripetizioni online soprattutto di latino, ed è stato in quel momento che ho raggiunto il limite di saturazione etica: chi viene promosso o chi non prende debiti a fine anno appartiene alla classe che ha i soldi per pagare una figura come me. Anche i voti, anche le promozioni, dipendono dalla classe. Durante il covid ho interrotto le prose in cui avevo iniziato a balbettare di lavoro, dal titolo Le case degli altri.
Nelle case degli altri è assente la polvere, un’assenza assertiva, limpida e cava, come se gli oggetti lucidi, da sempre e per sempre nuovi, inutilizzati, scavassero lo spazio intorno generandone ulteriormente. Tra gli oggetti, le numerose cornici espongono la prole nelle varie fasi dell’età evolutiva e nelle varie tappe esistenziali di una buona famiglia borghese cattolica, la prole messa al mondo per ereditare, per essere proprietaria delle case degli altri, la prole spaccata: una parte incastrata nelle foto a fissare per sempre gli ingressi, i corridoi, i salotti, i doppi salotti, le cucine, i bagni, i doppi bagni, i tripli bagni; e un’altra incastrata, già nevrotizzata, nella vita contingentata della buona famiglia borghese cattolica e divorziata: lunedì trinity college e il papà notaio, martedì ginnastica artistica o tennis, mercoledì equitazione o nuoto, giovedì canottaggio o ginnastica artistica, venerdì la madrelingua inglese o francese e poi il papà notaio, sabato equitazione o canottaggio, domenica la messa e il pranzo con la mamma avvocato. Intorno a un pezzo di prole la tata, l’insegnante privata, la madrelingua, l’istruttore, la mamma e due volte a settimana il papà; intorno a un altro pezzo di prole le cornici brillano, urlano niente polvere, riflettono un’ontologia impossibile.
Nelle case degli altri si entra in uno spazio esploso ordinatamente, uno spazio sicuro di sé, che si fa strada tra le mura allontanandole, evitandole, uno spazio altero, denso, profumato dai fiori nel vaso sul tavolo del salotto che nascondono la recisione obliqua, le bolle d’aria nei vasi linfatici, le punte del gambo combuste, la morte imminente; uno spazio colloidale che tiene immobile, conserva, i divani in pelle, i tavolini di cristallo, gli oggetti poggiati a una distanza razionale e funzionale tra loro; uno spazio dove tutto è terso, riflette e respinge la luce e gli sguardi, dove le cose accolgono la possibilità di possedere, non di appartenere; uno spazio che non finisce dove finisce, che si srotola rotolando gommoso tra i corridoi laocoontici, precipita oltre le terrazze, entra nella bocca atmosferica di Roma e rimbalza verso altre case degli altri.
Saturata dal senso di colpa della contraddizione etico-politica del classismo delle ripetizioni, e impossibilitata a continuare a lavorare nella ristorazione, mi sono iscritta al concorso ordinario per insegnare a scuola: non nei licei, ma nei ghetti tecnico-professionali, dove vengono segregate le ultime e gli ultimi. Shock totale. Ingenuamente ero convinta che mi sarei sentita a mio agio, tra la mia gente, aiutando finalmente la mia classe. Invece, mi sono resa conto che io della mia classe non sapevo nulla: avevo fatto il liceo in Prati, uno dei quartieri più borghesi di Roma, avevo studiato circondata dalla borghesia romana e provinciale, poi avevo lavorato per la borghesia romana, avevo frequentato le poete e i poeti borghesi, romani e italiani. Non sapevo nulla, ma soprattutto non ero assolutamente formata per il pezzo di mondo offeso in cui stavo per essere lanciata. Da quando lavoro come docente di italiano e storia a tempo indeterminato in un istituto alberghiero della periferia romana, ho scoperto che la mia classe di appartenenza, a cui forse non ho mai appartenuto davvero, è piena di fascisti, macisti, misogini, sessisti, razzisti, omofobi, violenti, neoliberisti, nazionalisti, indifferenti, cinici, disillusi, impolitici, opportunisti. Insomma, ho ritrovato in carne e ossa quel sottoproletariato così disprezzato da Marx, che nelle Lotte di classe in Francia lo definisce come il corrispettivo dell’aristocrazia finanziaria nelle basse sfere, composto da una massa di individualisti che perseguono solo i propri privati interessi e che si vendono al miglior offerente, in quel caso Napoleone III:
Accanto a libertini in dissesto, dalle risorse e dalle origini equivoche; accanto ad avventurieri corrotti, feccia della borghesia, vi si trovavano vagabondi, soldati in congedo, forzati usciti dal bagno, galeotti evasi, birbe, furfanti, lazzaroni, tagliaborse, ciurmatori, bari, ruffiani tenitori di postriboli, facchini, letterati, sonatori ambulanti, straccivendoli, arrotini, stagnini, accattoni, in una parola, tutta la massa confusa, decomposta, fluttuante, che i francesi chiamano la bohème. Con questi elementi a lui affini, Bonaparte aveva costituito il nucleo della Società del 10 dicembre. […] Questo Bonaparte, che si erige a capo del sottoproletariato; che soltanto in questo ambiente ritrova in forma di massa gli interessi da lui personalmente perseguiti, che in questo rifiuto, in questa feccia, in questa schiuma di tutte le classi riconosce la sola classe su cui egli può appoggiare senza riserve, è il vero Bonaparte.
Soprattutto: da quando lavoro come docente di italiano e storia a tempo indeterminato in un istituto alberghiero della periferia romana, non scrivo più. Forse perché non riuscirei a non parlare di lavoro.

La scoperta della letteratura working class
Ho scoperto la letteratura working class leggendo le poesie di Luigi Di Ruscio e poi Necrologi, un libro stratosferico e pressoché sconosciuto di Nadia Agustoni, una poeta operaia di Bergamo, di cui lancio due pezzettini per rendere l’idea:
le braccia abbiamo ferite. bruciature portate con magliette. siamo una pelle che ci sta dentro. alle 9 mi ricordo i mandarini la mela. il caffè lungo. o il the. nel the tanto zucchero. le macchinette del liofilizzato e quelle coi dolci. brioche a 60 centesimi di euro. al supermercato 6 con 1 euro e 20. oppure cioccolato. 1,50 il fondente di 100 grammi. la pausa dai 5 ai 7 minuti. la ritirata al gabinetto.
*
alle 10 le ossa. più o meno dolore. scricchiolo. il ritmo sale. calcolo dei pezzi appena fatti. il momento di accelerare. da una macchina all’altra. la fretta stringe il corpo a qualcosa. carichi e togli. ricarichi e limare. 4 per volta su una macchina. 8 su due macchine. le orecchie capiscono i rumori. le voci alte. arrivano a colpi. sentire parole intere no.
Riguardo la letteratura working class ho due posizioni tra loro non per forza in contrasto, anzi a mio avviso complementari e che sono esemplificate da due opere di un filosofo francese a me molto caro.
Nel 1976 Jacques Rancière cura, assieme ad Alain Faure, un volume dal titolo La parole ouvrière, in cui raccoglie e commenta gli scritti operai emersi tra l’indomani delle giornate di Luglio e l’ascesa di Luigi Bonaparte nel segmento storico 1830-1851. Qui la presa di parola degli operai è possibile a partire da un processo di soggettivazione politica collettiva, che viene presentata come risposta e reazione al torto subito. Nel loro prendere la parola gli operai descrivono le ingiustizie, i torti, il disprezzo che la classe borghese mostra nei loro confronti; rivendicano la propria dignità morale e intellettuale e si nominano politicamente. Quindi tematizzano la loro condizione, ne fanno contenuto artistico, letteratura di testimonianza e denuncia, letteratura working class.
Differentemente, nell’opera del 1981 intitolata La nuit des prolétaires. Archives du rêve ouvrier, la soggettivazione politica non è legata all’esperienza del torto e dell’ingiustizia. Qui Rancière, oltre a dimostrare che chiunque può diventare un soggetto politico e che tutte le intelligenze sono uguali, delinea il sogno che serpeggia nelle poesie degli operai: ovvero quello di non essere più operai, di dimostrare di poter godere di tutto ciò di cui sono stati privati, esattamente come i borghesi. Il sogno dell’uguaglianza dei sensi, ovvero dell’uguaglianza estetica.
La vita di una persona della classe lavoratrice all’interno del modo di produzione capitalistico è scandita da un tempo per produrre per qualcun altro in cambio di un salario, e un tempo per riprodurre (dormendo, mangiando, lavandosi, ecc.) quella forza-lavoro necessaria per lavorare. Rancière studia gli scritti di questi lavoratori che non rispettano la temporalità capitalista e generano al suo interno una discontinuità, usando la notte per fare ciò che non hanno il tempo di fare durante il giorno, ovvero pensare e scrivere, esattamente come un intellettuale borghese, semplicemente perché sono prima di tutto esseri umani. Hanno sottratto gli spazi e i tempi scanditi dall’ordine dell’utile e li hanno deviati, instaurando nuovi spazi e nuovi tempi di esistenza, ma anche svincolandosi dai temi della loro classe: non vogliono infatti raccontare del proprio lavoro, non vogliono essere schiacciati nell’identità di classe. Un po’ come Primo Levi che, tornato dai campi di sterminio, voleva scrivere racconti di fantascienza e non solo testi di testimonianza dell’orrore.
Rancière riflette a partire dal pensiero illuminista di Kant e quello comunista di Marx. Se il primo, in un momento storico in cui Voltaire poteva affermare che l’uomo colto ha sensi diversi rispetto all’uomo incolto, aveva proclamato l’universalità delle forme a priori dell’esperienza e delle categorie dell’intelletto, il secondo, nel Terzo dei Manoscritti del 1844, aveva definito il comunismo come lo stato in cui gli esseri umani sono liberi di sviluppare e di usare i propri sensi, comuni alla specie, e come lo stato in cui tale esercizio non è più sottomesso ai bisogni materiali. Questo universale sviluppo ed esercizio della sensibilità e intellettualità umana è impossibile all’interno del capitalismo, nel quale ci sono i proprietari che possiedono i beni, i mezzi di produzione, la lingua, le competenze, di cui i lavoratori sono espropriati, ma soprattutto nel quale entrambi, proprietari ed espropriati, si adattano al loro status, che è quello di avere dei sensi diversi che corrispondono al loro posto nel mondo. Per sabotare questo regime, chiamato da Rancière poliziesco, bisogna sradicarsi, riappropriarsi, profanare, trasformare i propri corpi, spogliarsi della propria identità operaia, dei tempi operai, dei modi di pensare, parlare ed essere della propria classe: diventare ubiqui, mutanti, vivere in due mondi e, probabilmente, sentirsi estranei in entrambi. Come succede a me, quando sto con le poete e i poeti borghesi italiani, ma anche quando sto con le compagne e i compagni della letteratura working class, con cui a volte non condivido i presupposti estetici.
In un intervento del 2017, pronunciato in occasione della mostra Sensibile comune. Le opere vive, presso la GNAM di Roma, Rancière, per spiegare cosa intenda per rivoluzione estetica e perché per lui la rivoluzione comunista sia anche una rivoluzione estetica, citava proprio un episodio del 1832. Il piastrellista Bergier, operaio istruito e appassionato di poesia, voleva convincere l’amico falegname Gaunay, anch’egli poeta, a unirsi alla comunità saintsimoniana che aveva fondato assieme ad altri, in una lettera nella quale citava il verso di Victor Hugo, I miei giorni se ne vanno di sogno in sogno. E lui così commentava:
Chi meglio di noi può sentire tutto il dolore espresso da questi versi, noi che abbiamo cercato così tante volte di mostrarci alla luce del giorno senza poterci riuscire; noi che conosciamo tutti i piaceri che Dio ha sparso sulla terra per tutti e che noi non abbiamo mai assaporato, se non con l’immaginazione?
Con questa lettera, secondo Rancière, il piastrellista Bergier opera due tipi di spossessamento o di rotture simboliche: prima di tutto rovesciando l’idea che l’operaio non abbia tempo (o addirittura le facoltà) per pensare alla poesia, figurarsi per scriverla, e sottraendolo al suo posto identitario; in secondo luogo, trasformandolo nell’unico a sapere che cosa significa, a capire davvero il verso del poeta borghese, spossessa la poesia borghese, la usa impropriamente, le fa esprimere una cosa probabilmente diversa da quella che il poeta borghese voleva dire: insomma, Bergier si è appropriato di qualcosa da cui era escluso.

La scoperta della convergenza
E poi è arrivata la GKN, o meglio: le lavoratrici e i lavoratori concreti e reali che ex abrupto il 9 luglio 2021 sono statə licenziatə dal cosiddetto proprietario della fabbrica a Campi Bisenzio (FI). Da lì in poi, è storia perché storia hanno voluto fare. Cercatela, leggetela, vi farà bene.
Una volta, vado a memoria, Dario Salvetti ha detto: vogliono che un operaio parli solo di calcio. Non gli va giù che parliamo di tutto il resto. Uno dei problemi è che a questə non basta parlare, prendere pubblicamente la parola, questə vogliono fare il nuovo che stenta a nascere, facendo una marea di cose: spettacoli teatrali, concerti, festival, cortei, manifestazioni, scioperi, comunicati, feste di capodanno in fabbrica; hanno scritto addirittura una proposta di legge regionale per la creazione di consorzi pubblici e un piano di riconversione industriale per una fabbrica socialmente integrata e polo delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile. Che oltraggio al regime poliziesco che detta dove devi stare, cosa devi pensare, dire, fare, produrre, scrivere, comprare!
Agamben, nel suo saggio del 2005 Elogio della profanazione, afferma che mentre la religione sottrae cose e luoghi all’uso comune e le trasferisce in una sfera separata, la profanazione restituisce le cose e i luoghi all’uso comune. Quello che non dice è quanta energie servano per fare tutto questo nuovo, tutti questi gesti di profanazione e spossessamento.
Non ho potuto essere presente a tutto quello che si sono inventatə dal 9 luglio del 2021 a oggi, ma a qualcosa sì: lo spettacolo teatrale Il capitale. Un libro che non abbiamo ancora letto, i vari cortei, e la seconda edizione del Festival della letteratura working class, organizzato nei pressi della fabbrica dal 5 al 7 aprile di quest’anno, nel quale hanno fatto convergere 5000 persone, hanno fatto vendere 2500 libri, con l’idea che il festival fosse parte costitutiva, strumento essenziale della lotta e della mobilitazione, perché la politica è immaginazione dell’altrimenti.
Il collettivo della GKN mi ha ricordato che la lotta non ha come obiettivo la presa del potere, bensì la rivoluzione sociale, che acquisisce così preminenza logica e temporale rispetto alla rivoluzione politica. Uno scritto polemico di Marx contro Ruge, Il re di Prussia e la riforma sociale, del 1844, si conclude con una riflessione che ribadisce la differenza tra rivoluzione politica borghese e rivoluzione sociale proletaria. La prima può raggiungere solo l’emancipazione politica ed è portata avanti da una classe che rappresenta una totalità astratta, esclusa dallo Stato e dal potere e che, dopo aver conquistato il potere, semplicemente, sostituisce la classe dirigente precedente. Solo la seconda compie l’emancipazione umana e, anche se è vero che ogni rivoluzione sociale è sempre un atto politico in quanto implica il rovesciamento del potere esistente e la dissoluzione dei vecchi rapporti, non è vero il contrario: ogni rivoluzione politica non è per forza sociale, non dissolve la vecchia società e lascia in piedi i pilastri della casa. Inoltre, la rivoluzione sociale è portata avanti da attori e attrici che possono dire io non sono nulla e dovrei essere tutto, che rappresentano la totalità per due motivi: prima di tutto perché sono singoli soggetti concreti e reali, poi perché protestano contro le condizioni di vita universali, di tutte e tutti.
La lotta è potente quando è sostanziata da creatività e inventiva, da energia calata nel tempo presente, da nuovi ethos, da nuove forme di vita, da nuovi modi di comunicare e di produrre. Perciò il conflitto delle lavoratrici e dei lavoratori della GKN ha come primario obiettivo la protezione e la salvaguardia di quel nuovo che hanno già istituito, la volontà di prolungarlo nel futuro. È questo il mirabile passo lungo che stanno compiendo: non una lotta privata per loro, ma per un’altra comunità, per un’altro mondo, per un’altra umanità, che, seppur in cattività, già esistono. Per questo, per altro, per tutto.
E quindi: non la presa del potere, bensì la convergenza, il contagio: è dal 1793 che i controrivoluzionari hanno paura del contagio, che continuino ad aver paura.
p.s. nelle ore in cui terminavo questo pezzo, è arrivata la notizia della decisione da parte del collettivo GKN di iniziare lo sciopero della fame. Come diceva Paolo Virno in un articolo di qualche anno fa, la lotta espleta la sua indole e i suoi obiettivi solo se si ha qualcosa da perdere oltre le proprie catene.

lay0ut cambia di nuovo forma.
Ci stiamo spogliando di tutti i nostri supporti, aiutaci a restare in piedi. Siamo senza scheletro e abbiamo bisogno di te!
Clicca qui per sapere quello che facciamo e per contribuire al primo crowdfunding di lay0ut: